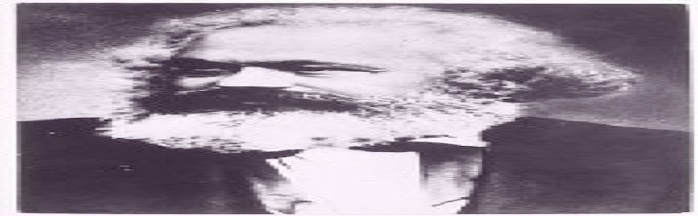uno strano attrattore
Uno strano attrattore (tempo, forze produttive, valori)
M
L'immagine di un tempo lineare che percorre gran parte della letteratura economica è intimamente legata non solo e non tanto a un'abitudine di pensiero e a una comodità di calcolo, quanto ad alcuni concetti chiave che sono parte forte dell'analisi della realtà sociale e storica, e in particolare a quello di forze produttive, come a quello di progresso che a queste è legato.
Probabilmente vi è accordo generale sul fatto che il progresso non sia concetto astratto e universale ma acquisti senso solo in relazione ad un contesto. Tuttavia
nella pratica applicazione appare prevalente un'immagine che possiamo rappresentare con l’analogia di un fiume: una corrente ben definita al centro, vortici ai margini; qua e là qualche lanca dove il flusso si arresta.
(Solo un poco più complessa l'immagine di Braudel: «Vi è un tempo straordinario che governa, a seconda dei luoghi e delle epoche, alcuni spazi e alcune realtà, ma altre realtà, altri spazi gli sfuggono e gli rimangono estranei". di tale quadrilatero soltanto i lati vivono veramente al passo coi tempi, accogliendo i traffici e i ritmi universali. Per priorità, i tempi del mondo attivano quelle linee viventi».]
Allo stesso Marx di “India, Cina, Russia” non è estranea un'ipotesi forte di questo tipo: forte nel senso di dare valore prevalente alla «corrente centrale».2
Se oggi tuttavia vogliamo cercare un senso preciso a questa analogia, e quindi una misura - per dire perlomeno cosa cambia - arriviamo presto a un aumento di complessità del quadro che si dimostra non riducibile a quell’immagine, portato di una fase storica determinata: quella del capitalismo «esplosivo» degli ultimi due secoli.
Già il concetto lineare di sviluppo delle forze produttive (intimamente legato a quello di progresso) é reso da Marx come processo contradditorio, dove la crisi e la conseguente distruzione di ricchezza giocano un ruolo decisivo nell’accumulazione e quindi nella riproduzione del capitale e delle strutture economiche.3
Quando poi si voglia fare un passo avanti rispetto alla semplice descrizione dello ‘sviluppo’ (oggetto scarsamente definibile ma probabilmente con andamento esponenziale anche se sussultorio) e si vogliano stabilire paragoni e quiondi utilizzare misure, si manifesta un senso di disagio crescente rispetto alla determinazione di un’unità di misura delle forze produttive, come anche alla determinazione del loro sviluppo nel tempo, in questo o in altri scenari.
L’apparire accanto alla massa dei beni fisici o alla massa monetaria di beni non isolati non quantificabili o non riproducibili (l’estendersi ad esempio delle singolarità legate alla scarsità di risorse, valori d’uso ‘naturali’ o di ‘qualità della vita’) se possono venir ricompresi all’interno dell’annoso dibattito sul rapporto consumi/bisogni e sulle sue forzature, acquistano però significato diverso se inseriti all’interno del problema della direzione d’uso delle forze produttive rispetto alla loro definizione originale (legata al dominio sul bisogno - e in primo luogo sulla natura, all’emancipazione dalla natura - e, infine, dalla costrizione sociale) in una fase in cui
si affaccia il sospetto del compimento già raggiunto di questo scopo originario, della chiusura del ciclo prima ancora logico che storico di definizione.
Se ancora rifiutiamo un’identificazione semplificata delle forze produttive con un’astratta e neutrale tecnica il contesto determinante è quello delle strutture economico-sociali.
(Va anche detto ad esempio che l’informatica, che nel dibattito appare una delle più ‘neutre’ tra le componenti dello sviluppo delle forze produttive - neutra in quanto se ne mettono in discussione modi e forme, non la coerenza con i bisogni - è di fatto interna a questa problematica, proprio perché si riferisce ad un livello di bisogni non primlari: per le produzione, ma anche per i sensi, per la comunicazione sociale e interpersonale, per lo sviluppo della potenza intellettuale, che sono definibili in modo univoco solo all’interno di una data fase storica e formazione sociale).
Se oggi tuttavia vogliamo cercare un senso preciso a questa analogia, e quindi una misura - per dire perlomeno cosa cambia - arriviamo presto a un aumento di complessità del quadro che si dimostra non riducibile a quell’immagine, portato di una fase storica determinata: quella del capitalismo «esplosivo» degli ultimi due secoli.
Le possibilità di mutamento delle strutture sociali e delle forze produttive sono interconnesse alle possibilità di pianificazione.
Quando si osserva l'evoluzione, i percorsi di questi elementi, si notano i cicli, i ricorsi, gli stalli, si vede la possibilità/necessità di rinunciare ad un tempo lineare,
immaginando una linea forse topologicamente omogenea ma non più dotata di una metrica uniforme (è su quest'asse che possiamo ancora avere l'illusione del movimento quando l0 sviluppo si è già fermato).
E insieme l'opportunità di legare le forze produttive non solo o non tanto ad un insieme di beni prodotti, di forze messe in movimento, ma all'evoluzione di strutture; e di conseguenza una misurazione non più necessariamente linearizzabile.
Possono qui entrare in gioco a buon diritto quei problemi di «ordine internazionale», di rottura o creazione di strutture sociali, che nella visione immediatamente materiale delle forze produttive spariscono e che non sono misurabili all'interno di una concezione delle formazioni sociali come mosse dalle forze produttive stesse.
Emerge quindi un problema di ordinamento delle strutture, sia riferito ad un insieme - reale o potenziale di strutture diverse, sia riferito all'evoluzione di una singola struttura come successione monotona di strutture similari.
Gli elementi di provvisorietà e di arbitrio insiti in questa operazione possono venir ridotti qualora si riesca a definire - con un sufficiente grado di verificabilità - una soglia di passaggio dal «regno della necessità» al «regno della libertà”.
L'analisi è però complicata dalla difficoltà di individuazione di traiettorie definite, conseguenza della perdita di una unità di valutazione standard. D'altronde è risultato inevitabile della perdita di quelle semplificazioni comode, epperò falsanti, legate alla linearità. (Citando Thom: «L'area della scienza dove è possibile costruire modelli quantitativi esatti e permettere previsioni e quindi l'azione è molto più piccola di quanto comunemente si creda; , .. nei sistemi complessi ... il formalismo elude la valutazione analitica e di conseguenza la teoria può solo utilizzare modelli semplicistici che sono largamente inadatti a rappresentare lo sviluppo di un sistema reale. Ê probabile che sia possibile ottenere solo conclusioni qualitative sulla natura degli stati asintotici/punti di equilibrio, cicli limite, strani attrattori ... »).'
Un'altra considerazione necessaria riguarda il fatto che l'evoluzione di questi due secoli non ha generato strutture omogenee all'interno delle singole unità statuali, ma ha mantenuto o generato un ampio ventaglio di sottostrutture: se quindi in astratto potremmo immaginare un'evoluzione monotona all'interno di queste (il paragone più immediato è un sottosistema agricolo che sviluppa i metodi di produzione con tecniche via via più efficienti), tuttavia questo processo non si dà senza mutamento dei rapporti sociali, senza uno scontro con le stesse forze di regolazione della produzione e del mercato.
La concorrenza e più in generale la legge del valore sono meccanismi competitivi, che distruggono gli equilibri tecnici e locali.
Siamo quindi rimandati al mutamento come processo dinamico, di passaggio a strutture diverse; sia rispetto a questo elemento, sia rispetto alla freccia del tempo sociale che segue traiettorie in generale non lineari
dobbiamo rinunciare a quanto di evolutivo e dolcemente progressivo è insito nel termine di progresso.
Se avviciniamo il nostro punto di osservazione al sistema economico non è forse un caso se troviamo al centro del dibattito teorico una proposta «astratta» come quella di Sraffa per la misura - la merce-base - che, nata all'interno di un apparato di critica della teoria marginalista, viene da alcuni sviluppata come aggregato dinamico in relazione a forme diverse di sviluppo: suscettibile anche di definizioni tendenziose che la ricollegano all'insieme dei beni salario, ma soprattutto interessante là dove allude ad un insieme di elementi «socialmente necessari» e «produttivi» in relazione a fasi e formazioni .
Ricordiamo anche Pasinetti: «In presenza di progresso tecnico qualsiasi relazione matematica in cui i beni capitali siano espressi in quantità fisiche ordinarie diventa inservibile per l’analisi dinamica».6 In termini paralleli si esprime Schefold: «L'impulso principale del progresso capitalistico assume forme che potrebbero essere analizzate in modo abbastanza adeguato in termini della teoria del valore-lavoro. Nei limiti in cui quest'ultima è inadeguata, il capitalismo stesso non dà affidamento: o si adatta alla "legge del valore" o il progresso tecnico può non essere affatto progresso». 7
Vale probabilmente la pena di soffermarsi su di un altro aspetto della questione relativo alle forze produttive: vi è una distinzione fondamentale - in Marx come già in Smith e in Quesnay - tra lavoro produttivo e improduttivo. I diversi livelli a cui questa definizione deve essere contemporaneamente operativa hanno portato a numerose difficoltà logiche, in quanto non sembra darsi una definizione unica per i diversi piani di riferimento in relazione all'insieme dei soggetti sociali sotto stanti le categorie economiche: sul piano dei valori di scambio, su quello dei valori d'uso prodotti, su quello dei processi di produzione diretta o indiretta, sulle varie fasi di riproduzione del capitale, e infine sul confronto tra formazioni sociali diverse e diversi rapporti di produzione.
Il tentativo di ricercare a questo livello un elemento primario vuoi come in Quesnay nella produzione dei beni fondamentali (nel suo caso l'agricoltura), vuoi ricollegati alla tecnica e quindi all'industria successivamente - si scontra con quell'elemento centrale che è in Marx (ma poi trasmigrato in larga parte nell'economia politica) lo scambio capitale-lavoro, e quindi la definizione di produttivo per tutto quel lavoro che entra nella riproduzione allargata del capitale; laddove una limitazione in termini sociali è possibile soprattutto in quanto le forze messe in moto sono tali da superare la base capitalistica della produzione e negare quindi la definizione stessa di produttivo in quanto legata ad una determinazione sociale data,diverse.5
Sono fondamentali dunque ancora le traiettorie dinamiche. Pensiamo, rispetto a questo, a due fenomeni della fase attuale: il peso crescente nel processo di produzione di processi ad. alta intensità di lavoro intellettuale accumulato (il che comprende settori chiamati terziario avanzato, «soft», ma non solo); e l'allentarsi di alcuni dei vincoli formali dei produttori col capitale (il che comprende fenomeni distanti come i lavoratori a domicilio della produzione diffusa, i contadini dei paesi arretrati soggetti al mercato internazionale come i piccoli «artigiani» delle imprese di software).
In quanto questo processo sia abbastanza generale e non semplicemente temporaneo e quindi
la sussunzione del lavoro sotto il dominio del capitale non appaia necessariamente connesso con la vendita della forza-lavoro e il suo diretto reificarsi come altro da sé (in una sorta di interregno fluido e spurio che tuttavia non sembra sparire ma configurare nuove dimensioni della frontiera delle forze produttive),
e in quanto appare concentrata qui una parte assai significativa di produttività (e quindi il riferimento al tempo medio/più avanzato come criterio di misura del valore) la misurazione delle forze produttive diviene problematica anche in un'ottica classica, Se questo rimanda all'apertura di un discorso sul nuovo ruolo delle istituzioni statuali e politiche in questo contesto di controllo indiretto, si può però sottolineare l'apparire in questo ambito di una contraddizione con l'aumento della cooperazione sociale, con una dialettica tra forme interne di controllo e di appropriazione e forme di espansione e sviluppo della cooperazione libera.
D'altronde è questo avvicinamento tra tutti i punti-soggetti, provocato dalle nuove tecnologie in generale e da quelle dell'informazione in particolare che provoca i livelli di contraddizione più palesi - e in generale di instabilità - per l'aumento che induce sulla complessità del sistema.
Un ulteriore livello è nella diffusione delle tecnologie (in quanto sottoinsieme o emblema delle forze produttive) che non compare come processo uniforme nel tempo e nello spazio' ma mantiene e spesso accentua le polarizzazioni esistenti, pur generando percorsi strutturati anche anomali a causa non solo degli effetti di accumulazione ma anche di punti di biforcazione legati ad elementi di «memoria» non immediatamente identificabili. Ma, passando questi processi diffusivi attraverso le frontiere di sistemi economico-sociali, di stati ed entità in qualche modo regolati, il loro potere unificante (nel senso del valore) viene mediato e ridotto, tanto più quanto è maggiore il grado di regolazione o autonomia del sistema (o viceversa opera perequazioni esplosive a scapito delle strutture preesistenti).
Dunque ancora una volta una non-linearità nella misura di valori e forze produttive, là anche dove quest'ultime sono definite solo all'interno di processi finalizzati (il che è garantito a priori solo nel caso di forme pianificate),
Conviene sottolineare come la mancanza di linearità dei processi abbia implicite delle conseguenze rilevanti per l'analisi: da un lato la mancanza di simmetria temporale, il che non è molto importante per l'economia reale ma dovrebbe però essere anche una caratteristica essenziale dei modelli - il che in generale non accade; un modello dotato di memoriaB mostra la presenza di soglie di saturazione che possono anche portare all'inversione di segno di alcune grandezze ma non alla reversione del fenomeno - che presuppone l'inversione di segno di tutte le grandezze; pensiamo allora al raggiungimento di limiti critici per l'omeostasi complessiva dell'ambiente strutturato, sia dal lato naturale (effetto serra, esaurimento di risorse naturali, rottura di equilibri critici dell'ecosistema) sia dal lato del controllo politico sociale (moltiplicazione dei luoghi di conflitto).
Questi fenomeni appaiono comprensibili se si abbandona l'ottica della reversibilità - associata all'equilibrio e alla linearità - correlata anche ai cicli lunghi e alle attese di ristabilimento di cicli ‘normali’ e si ragiona in termini di compressione dei tempi con conseguente esasperazione esplosiva di alcuni fenomeni.
Le stesse fluttuazioni casuali che, passando attraverso la frontiera «filtrata» di un sistema economico vengono smorzate e rese inoffensive, in una scala accelerata possono produrre mutamenti sensibili, soprattutto dove intervengono su strutture già in equilibrio instabile o metastabile.
Questo elemento si correla alla seconda conseguenza della non linearità: la mancanza di prevedibilità (non di intellegibilità) dei fenomeni; e alla terza, cioè la presenza o compresenza di scale dei tempi diverse in archi temporali prossimi.
Possiamo riprendere i termini del ragionamento per indicare due conclusioni provvisorie: in primo luogo non è possibile - o meglio conveniente - considerare le forze produttive fuori da un contesto economico e sociale determinato, più ancora, fuori da una realtà «locale» (in termini di geometria strutturale/temporale) che non coincide con l'intero arco temporale di una forma specifica dei rapporti di produzione; e in particolare avulse dalle possibilità di regolazione offerte in una determinata fase e nei suoi prolungamenti.
Le possibilità di mutamento delle strutture sociali e delle forze produttive che operano in un luogo dato sono interconnesse alle possibilità di pianificazione:
la forma stato governa il mutamento all'interno di una singola struttura, là dove sia data una traiettoria monotona. In secondo luogo possiamo osservare, riprendendo la nota immagine, che
non abbiamo una sola uscita dal tempo della preistoria, ma più uscite possibili, con fuochi locali; e lungo le traiettorie del mutamento condizione di governo del processo è un osservatore locale «privilegiato», di cui la forma partito appare l'equivalente più prossimo.
___________________________________________________________________________________________________
1. F. Braudel, Civiltà materiale, economia e capitalismo, voI. IlI, pp. XXIII seg., Einaudi, Torino, 1982.
2. K. Marx, La dominazione britannica in India', in India, Cina, Russia, pp. 61-62, Il Saggiatore, Milano, 1960.
4. R. Thom, Mathematics and Scientific Theorizing, pp. 28-33, in Scientific Culture in the Contemporary World, «Scientia», Milano, 1979.
5. P. Sraffa, Produzione di merci a mezzo di merci, Einaudi, Torino, 1960.
6. L. Pasinetti, Introduzione a Contributi alla teoria della produzione congiunta, Il Mulino, Bologna, 1977.
7. B. Schefold, Capitale fisso, accumulazione e progresso tecnico, in Contributi ... (v. 7).
8. v.dM, Strutture ambientali e pianificazione territoriale. Alcuni problemi di metodo nell'analisi economica locale Studi di Economia e Finanza, ETS 1981-82/13)