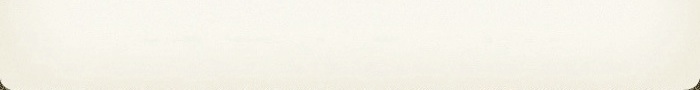materiali
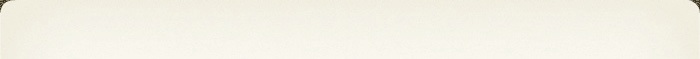


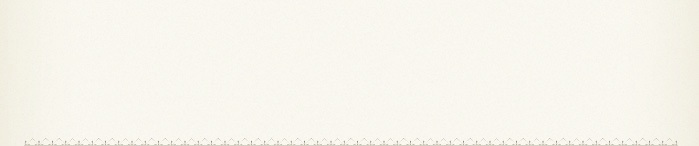
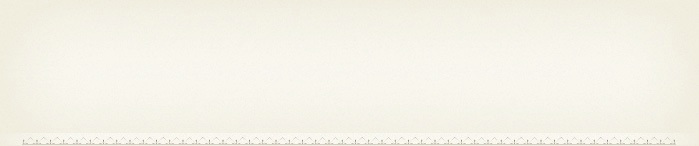

STORIA E VITA DI DON VITO GUARRASI, L’UOMO “PIU’ SEGRETO DI FATIMA”, IL BOSS DEI DUE MONDI (MAI CONDANNATO) AL COSPETTO DEL QUALE SI INCHINAVANO TUTTI, DAI PIU’ SANGUINARI CAPIMAFIA AI GRANDI CAPITALISTI ITALIANI - UN RAPPORTO DEL 1944 DEL DIPARTIMENTO DI STATO USA LO INDICA TRA I COMPONENTI DI SPICCO DI COSA NOSTRA - AMICO DI EMANUELE MACALUSO E LONTANO PARENTE DI ENRICO CUCCIA, MASSONE DI RAZZA, GUARRASI ERA PER TUTTI “MISTER X”….
Il capitolo su Vito Guarrasi del libro "I Siciliani" di Alfio Caruso. Edizioni Neri Pozza
Poco tempo prima di morire (1999) disse: «Mi liquideranno con due parole molto siciliane. Fu un uomo intelligente e chiacchierato». Forse è stata una delle poche profezie sbagliate da Vito Guarrasi, che in vita venne omaggiato da complici silenzi alternati a riverenti definizioni: «uomo dei misteri», «inafferrabile suggeritore», «eminenza grigia». È emerso che fu molto di piú e che l'aggettivo «chiacchierato» è assai assolutorio per un personaggio incombente su oltre mezzo secolo d'intrighi.
Nasce ad Alcamo (1914), ma il centro d'attrazione è già la Palermo che assiste impotente alla decadenza dei Florio e del proprio ruolo di metropoli internazionale. Il padre è un ricco proprietario terriero, nei suoi vigneti si produce il famoso Rapitalà, la madre è una Hugony, famiglia di agiati commercianti. La giovinezza è spensierata in compagnia di tanti bei nomi. In mezzo anche i fratelli Lanza di Trabia, Raimondo e Galvano: l'amico di sempre diventerà Galvano, ma allorché s'affaccia sulla Grande Storia accompagna Raimondo, se è vera la diceria - mai smentita, mai confermata - che i due insieme con il colonnello Pompeo Agrifoglio del SIM partecipano nel maggio '43 a una serie d'incontri ad Algeri con gli ufficiali alleati.
Obiettivo: la pianificazione dell'imminente invasione della Sicilia. In quei giorni la malridotta armata di Messe sta ancora combattendo contro le truppe di Eisenhower; Stati Uniti e Gran Bretagna sono ancora i nostri nemici, tuttavia alcuni ambienti privilegiati preparano già la svolta, che cancellerà fascismo e monarchia. E di questa svolta due cardini sono i ragazzi ben nati venuti dalla Sicilia e rappresentanti di un potere in grado di travalicare qualsiasi sistema statuale.
Raimondo ha dietro di sé un casato millenario, il proprio passato di spaccone, le conoscenze altolocate, una spessa predisposizione ai giochi spericolati. Di Guarrasi, capitano del genio, si sussurra che abbia collaborato con il servizio segreto del generale Roatta subito dopo la laurea, che già sul finire degli anni Trenta abbia svolto una delicata missione a Tripoli, dove il governatore Balbo era sott'osservazione di Mussolini e gli amici palermitani di don Mimí Guarnaschelli gestivano il casinò.
Se davvero l'abboccamento di Algeri è avvenuto, si spiega perché Guarrasi e Raimondo Lanza di Trabia, assieme a Galvano e a un quarto ufficiale, indicato spesso in Stefano La Motta, fumino e passeggino a Cassibile davanti alla tenda sotto la quale il generale Castellano è impegnato, il 3 settembre, a firmare l'armistizio. Per come è maturato, annuncia i futuri problemi ed equivoci: rappresenta la nebulosa da cui discenderanno tutte le opacità dell'Italia repubblicana.
Eisenhower, che da presidente degli Stati Uniti sarà l'affettuoso anfitrione di Galvano Lanza di Trabia alla Casa Bianca, ha vietato a fotografi e cineoperatori di riprendere i quattro con la divisa dell'esercito italiano. Un'interpretazione maliziosa assegna ai rampanti giovanotti un ruolo addirittura preminente rispetto agli emissari dei Savoia (oltre Castellano, il diplomatico Montanari, il maggiore del SIM, Marchesi, il capitano Vassallo, che ha pilotato l'idrovolante da Guidonia a Termini Imerese).
Decenni dopo Guarrasi spiegherà che il 3 settembre '43 stava a Cassibile da aiutante di campo di Castellano, nei registri, però, non se ne trova traccia. Guarrasi e gli altri sono lí in rappresentanza di un potere molto piú ampio e penetrante, di cui la massoneria è il garante al cospetto delle potenze alleate. Lui e Galvano Lanza di Trabia diventano un binomio inscindibile. A nome dell'amico incontra nello studio dell'avvocato Biuso il sospettoso Momo Li Causi e un giovanissimo Emanuele Macaluso.
Ai due interlocutori propone un accordo per far cessare l'occupazione contadina e bracciantile dei feudi dei Lanza fra Caltanissetta e Palermo, che egli poi si vanterà di aver sottratto alle cure rapaci di Vizzini e di Genco Russo. I due rappresentanti del PCI ascoltano trasecolati: Guarrasi afferma di esser di Sinistra, ma ha già cominciato a fungere da sintesi d'interessi contrapposti. In ogni occasione si arroga la parola definitiva, offre la soluzione senza alternativa. E se i piú deboli protestano, se qualcuno constata che cosí "sperti e malandrini" hanno vinto una volta di piú sbatte contro il suo ghigno di manifesta superiorità. Eppure con Macaluso s'instaura una solida e duratura amicizia.
Guarrasi è socialista e candidato, da autonomista borghese e di Sinistra, del Blocco del popolo alle elezioni regionali del '47. È cattolico devotissimo, da messa ogni mattina, spesso accompagnata dalla comunione, però lo dicono iscritto in logge riservatissime e lui, per via del raffinato cinismo in cui ama crogiolarsi, mai lo ha smentito.
Si barcamena tra indipendentisti e nazionalisti, come in futuro farà tra liberali e radicali, fra democristiani e comunisti: dà l'idea di voler accarezzare tutti, ma parteggia soltanto per se stesso. Partecipa alla stesura dello statuto autonomista della Sicilia, scrive le principali leggi - «perché i politici spesso non ne sono capaci» - e nel farlo può capitare che si lasci aperte le porte per qualche favorevole interpretazione. Lamenta l'inesistenza della borghesia siciliana, ma viene additato come l'avvocato della borghesia mafiosa.
Un rapporto del 1944 custodito a Washington nell'archivio del Dipartimento di Stato si spinge piú avanti: lo indica tra i componenti di spicco di Cosa Nostra, che ai suoi occhi deve apparire troppo zotica dato che mai trova il tempo di parlarne, di stigmatizzarla. Difende strenuamente l'importanza della Regione, tuttavia le assesta colpi economici micidiali facendo prevalere le dubbie ragioni dei propri clienti. Da socio fondatore di una cooperativa avvia nel '47 la sua avventura nei consigli d'amministrazione. Sarà azionista, consigliere, presidente di venticinque società, in maggioranza pubbliche.
Nel lotto una banca, il quotidiano paracomunista L'Ora, il Palermo calcio, la Ra.Spe.Me. Spa, operante nel settore medico e qui il suo socio è Alfredo Dell'Utri, il papà di Marcello. Apre le braccia a Verzotto, proconsole nell'isola di Mattei, e allo stesso padrepadrone dell'ENI. La Sicilia è disorientata dalle promesse di Mattei. Il petrolio suscita enormi speranze, promette quattrini a palate: Guarrasi è incaricato di tessere i fili di un accordo che accontenti il PUS nella sua interezza.
E quando l'asse mafioso-massonico-politico avverte che Fanfani e Moro hanno intenzione di cambiare cavallo, di aprire ai socialisti parte l'avvertimento, grazie al quale in tanti sperano di ritagliarsi un tornaconto. Fiorisce il governo anomalo di Milazzo, che nell'abusato nome dell'autonomia mette assieme fascisti e comunisti, socialisti e democristiani. In realtà è il primo governo della mafia: i grandi burattinai sono don Paolino Bontate e Guarrasi, i soldi li mettono gli esattori e gl'imprenditori catanesi Costanzo. Guarrasi è talmente bravo e convincente da attirare nella propria rete persino Macaluso. Vengono beneficiati gli esattori Cambria e Corleo, il suocero di Nino Salvo, e i proprietari delle miniere di zolfo.
Milazzo nomina Guarrasi responsabile del piano quinquennale di rinascita, lui promuove una legge, che istituisce presso il Banco di Sicilia un fondo di rotazione delle miniere di zolfo. Vengono cosí trasferiti alla Regione dodici miliardi di debiti contratti dai proprietari delle miniere con il Banco di Sicilia medesimo. In pratica significa il salvataggio delle famiglie nobiliari padrone delle miniere, il passaggio delle stesse sotto la mano pubblica. Il commento piú pertinente appartiene a Sciascia: «Nulla capiremo della mafia, finché non metteremo in luce gli aspetti di questa vicenda». Conclusasi in un'atmosfera da pochade l'esperienza Milazzo, il funambolico avvocato aiuta il gruppo Corleo-Salvo a preservare l'appalto della riscossione.
La Regione presieduta dal democristiano D'Angelo vorrebbe riappropriarsene, per gli esattori sarebbe un colpo mortale: perderebbero la mammella da cui mungono ogni anno decine e decine di miliardi quando a Palermo un palazzo di cinque piani con venti appartamenti costa centocinquanta milioni. Morto Mattei, per conto del quale si è occupato del gasdotto tra l'Algeria e la Sicilia, Guarrasi stabilisce un buon rapporto con il successore, Cefis. Il legame negli anni ha indotto i nemici di Cefis ad attribuire a Guarrasi una parte significativa nella congiura per assassinare - ormai esistono pochi dubbi - l'ingombrante presidente dell'ENI.
E in tal caso la pista sarebbe tutta italiana. Secondo Pietro Zullino, giornalista di «Epoca», un settimanale all'epoca assai quotato, «Cefis aveva forti cointeressenze nelle raffinerie Sarom di Ravenna e Mediterranea di Gaeta. Queste raffinerie sono tra le principali rifornitrici del sistema difensivo NATO per il sud-Europa e della Sesta Flotta americana; raffinano e vendono petrolio Esso e Shell. Mattei cercava di obbligare la NATO mediterranea a diventare cliente dell'ENI; Cefis si opponeva a questo progetto, per via delle sue cointeressenze».
Accanto a questa contrapposizione quasi personale, ne campeggia un'altra geopolitica molto piú pregnante: il gasdotto Algeri- Gela avrebbe frustrato molti interessi di potenti personaggi coinvolti nelle società di navigazione incaricate di assicurare il trasporto di gas e petrolio dalle coste africane all'Italia. E che costoro fossero supportati da politici di primo piano della DC intorbidisce viepiú l'intrigo. Tesi, congetture, maldicenze, che mai hanno trovato lo straccio di una prova convincente. Guarrasi esce trionfante da ogni sospetto. Le rare imputazioni ricevute nei decenni si sono sempre concluse con il proscioglimento. Viene tirato in ballo anche per la scomparsa di Mauro De Mauro.
Il giornalista stava indagando sugli ultimi giorni di Mattei, ha incontrato fra gli altri l'avvocato. Qualcuno si spinge ad azzardare che De Mauro si sia infilato in un gioco di sotterranee pressioni fra Verzotto e Guarrasi e ne sia rimasto schiacciato. Ipotesi rafforzata dall'inatteso ingresso in scena del commercialista Nino Buttafuoco, che all'inizio della sparizione si sforza di tranquillizzare la moglie e le figlie di De Mauro, ne garantisce il ritorno a casa. S'intravede l'abituale, perverso intreccio di massoneria, Cosa Nostra, servizi segreti, sottobosco politico: in una parola Guarrasi. I giornali non hanno il coraggio di nominarlo, scrivono Mister X.
Vengono querelati lo stesso, finisce con la consueta glorificazione di Guarrasi, benché l'ex questore Li Donni nel rapporto inviato alla Commissione antimafia sostenga che il binomio Guarrasi-Galvano Lanza di Trabia costituisca uno dei piú forti gruppi di potere nel panorama siciliano. Nel '76 il senatore democristiano Luigi Carraro, presidente della commissione, mette in luce nella relazione conclusiva le trame, la vastità d'interessi, l'influenza dell'avvocato. Insorge in sua difesa il PCI: spiega che Guarrasi è un avvocato d'affari al pari di tanti altri, che l'unica differenza, ed è anche il motivo della sua persecuzione, consiste nell'aver qualche volta assecondato i progetti della Sinistra. Non è l'unico intervento in sperticata difesa di Guarrasi.
Il vecchio sodale Macaluso, da direttore dell'Unità, invia al ministro dell'Interno un'accalorata reprimenda contro il questore Angelo Mangano, colpevole di aver pubblicamente definito l'avvocato la testa pensante della mafia. Chissà se i notabili comunisti avrebbero mantenuto l'identico parere qualora li avessero informati che il pupillo fungeva da camera di compensazione, anche al di fuori della Sicilia, negli equilibri instabili dei massimi poteri, dove il capitalismo assume la fisionomia piú torva. Un episodio lo dimostra appieno: la perentoria convocazione, a metà degli anni Settanta, di Cefis, Girotti e Rovelli nella splendida villa di Guarrasi a Mondello.
I tre, rispettivamente presidenti della Montedison, dell'ENI e della SIR, la piú grande impresa chimica privata, da tempo guerreggiavano di brutto per assicurarsi i proventi del mercato all'epoca piú pingue. È stato Cuccia a suggerire, cioè a ordinare, che raggiungano Palermo e si affidino alle arti magiche dell'avvocato per trovare un'intesa. I tre hanno ubbidito con celerità. I loro aerei privati li hanno sbarcati a Punta Raisi, auto scure li hanno condotti a destinazione. Dopo lunghe ore l'accordo è stato siglato, ma il vertice e i suoi protagonisti rimarranno a lungo ignoti.
L'aneddoto serve pure a smentire che Guarrasi e Cuccia, parenti alla lontana (uno zio dell'uno ha sposato una zia dell'altro) s'ignorassero. Tutt'altro: erano due facce dello stesso, silenzioso potere esercitato con ogni mezzo. La leggenda narra che nei rari e appartati incontri Cuccia si presentasse in fumo di Londra, a prescindere dalle stagioni; Guarrasi in lino chiaro, panama e sigaro d'estate, in regolamentare tre pezzi scuro negli altri mesi, ma sempre con il sigaro, di cui Cuccia non sopportava la puzza. S'incontravano a Milano dentro appartamenti discreti: Guarrasi portava una delle sue bottiglie di Rapitalà, Cuccia ricambiava con il testo di un memorialista francese. Montanelli garantiva che ne fosse il massimo cultore in Italia.
L'assassinio del commissario Boris Giuliano, commesso da Leoluca Bagarella, riporta nel '79 Guarrasi sotto la luce dei riflettori. Qualche magistrato scorge un filo che lega Mattei-De Mauro-Giuliano: l'avvocato ne sa qualcosa? L'avvocato respinge sdegnoso ogni insinuazione, attribuisce il proprio coinvolgimento all'invidia dell'immancabile quaquaraquà. Eppure il giudice istruttore Chinnici nel diario reso pubblico, dopo che un'autobomba l'ha dilaniato, sotto la data 14 luglio 1981 annota: «Viene a trovarmi il marchese De Seta; dopo avermi raccontato delle sue vicende con l'avvocato Guarrasi, mi fa presente che costui è intimo amico del senatore Emanuele Macaluso.
Mi riferisce che alla galleria d'arte la Tavolozza (il cui proprietario effettivo è Renato Guttuso) si recava spesso il dottor Boris Giuliano (capo della squadra mobile) il quale, in quella sede, parlando con Leonardo Sciascia e qualche altro, si riteneva certo che il responsabile del sequestro De Mauro era proprio il Guarrasi». A Palermo il '79 è l'anno dei troppi delitti irrisolti: il cronista di punta del Giornale di Sicilia, Mario Francese; il segretario provinciale della DC, Michele Reina; il giudice istruttore Terranova, ammazzato assieme all'agente- autista Lenin Mancuso. È anche l'anno dell'irruzione nell'isola di Michele Sindona, che ha già fatto sopprimere l'avvocato Ambrosoli a Milano.
Sindona insegue un azzardo disperato in grado di tacitare le minacce di morte dei fratelli Gambino di Cherry Hill. Il collaboratore di giustizia Angelo Siino racconterà ai giudici di aver accompagnato in quel periodo Sindona in svariate visite alla villa di Guarrasi. Lui negherà sul filo della logica: «Escludo che Sindona abbia potuto pensare a me: ero considerato amico di Enrico Cuccia, suo grande avversario». Ma Sindona appena pochi mesi prima aveva costretto l'imperatore di Mediobanca a correre in incognito a New York per ascoltare, senza replicare, invettive e minacce.
Guarrasi appare talmente intoccabile che nessuno si stupisce di vederlo comparire nello sterminato elenco della «Massoneria universale di rito scozzese antico e accettato. Supremo Consiglio d'Italia. Sezione Sicilia». Dietro la targhetta bianca al secondo piano del dissestato palazzotto liberty di via Roma 391 viene individuata nel 1986 la sede di una mezza dozzina di logge. Nello stanzino nero, oltre magistrati, dentisti, generali, avvocati, professori universitari sono stati iniziati i fratelli Greco, il commercialista Nino Buttafuoco, il vecchio editore del Giornale di Sicilia, Federico Ardizzone, Nino Salvo e suo fratello Alberto.
Costituiscono la quintessenza del PUS: può non starci l'avvocato che di se stesso dice: «Sono come il medico: mi chiamano in situazioni disperate quando hanno bisogno di farsi tirare fuori dai guai»? Quindi non possono essere simili seccature a offuscare la stella di Guarrasi. Resta sempre accesa, è quanto mai ricercata e apprezzata. In special modo allorché bisogna sfruttare le Istituzioni. Succede con la società dei sali minerari, la Italkali, a capitale misto: i soldi provengono dai fondi regionali, le decisioni le prende il socio privato.
Secondo alcuni deputati regionali e secondo la procura di Palermo si registra però un eccesso di furbizia nel licenziamento degli operai e nei miliardi d'indennizzo sganciati dalla Regione alla Italkali per il mancato funzionamento degli impianti. Il caso impazza per anni e anni, spedisce in galera fior di personaggi, ma non Guarrasi. La morte, anzi, gl'impedisce di assistere al clamoroso incartamento della vicenda giudiziaria, alla sopravvivenza della Italkali, boccone prelibato delle nomine financo con Lombardo. Un trionfo postumo dell'avvocato, la consacrazione definitiva del suo modus operandi.
_______________________________________________________________________
L'INCHIESTA/Chi comanda nelle grandi città
Palermo sommersa
dal partito del nulla
di ALBERTO STATERA
Palermo, Palazzo dei Normanni. La Sala d'Ercole durante una seduta dell'assemblea regionale sicilianaPALERMO - A Milano non c'è più Enrico Cuccia, a Palermo non c'è più Vito Guarrasi. "Cu è chistu?". È la sicula, storica incarnazione del potere. Scomparsi adesso i due massimi sacerdoti del potere nelle due Italie, che nel potere talvolta si ricomponevano, tutto si frantuma, si scombina in un bradisismo che confonde le linee di comando e ne fa una poltiglia persino qui nella patria del "cummannari è megghiu che futtiri". Pochi lo sanno, ma Enrico Cuccia, originario di Piana degli Albanesi, e Vito Guarrasi erano cugini.
Diversi: l'uno un omino grigio in eterno fumo di Londra, l'altro in regolamentare lino chiaro, panama e sigaro, si vedevano, si consultavano, scherzavano persino, con l'autoironia dei veri potenti, sul loro potere e sulla reciproca cattiva fama, come confessò il gran khan palermitano prima di morire.
Oggi se a Palermo chiedi di Guarrasi ti rispondono, per l'appunto: "Cu è?". Originario di Alcamo, dove la sua famiglia possedeva i vigneti "Rapitalà", giovane aiutante del generale Giuseppe Castellano fu testimone dell'armistizio di Cassibile con gli anglo-americani. Nei decenni successivi, non c'è stato evento siciliano o nazionale, politico o economico, che non lo abbia visto, sempre a cavallo tra democristiani e comunisti, protagonista silente e tenebroso: dall'autonomia regionale al milazzismo, dall'assassinio di Enrico Mattei alla bancarotta di Michele Sindona, dal finto rapimento di Graziano Verzotto - veneto di Padova diventato vicerè della Sicilia democristian-mafiosa come i veneti Silvio e Antonio Gava lo furono della Napoli democristian-camorrista - fino alla scomparsa di Mauro De Mauro. L'industria del sale, poi il petrolio, le esattorie delle imposte appaltate ai cugini Nino e Ignazio Salvo, le imprese irizzate o enizzate, la politica e gli affari furono, nel bene e più spesso nel male, il pane quotidiano dell'avvocato Guarrasi, che in Sicilia incarnò la "stanza di compensazione" dei poteri legali e illegali. Un Cuccia in salsa siciliana. Che non c'è più, come il cugino siculo-milanese di via Filodrammatici.
Oggi sbarchi a Punta Raisi, aeroporto "Falcone-Borsellino", chiedi chi comanda e ti guardano come un marziano. Non solo Guarrasi, non c'è più Salvo Lima, né il cardinale Ernesto Ruffini né l'ex ministro delle Partecipazioni statali Nino Gullotti.
Non ci sono più i Cavalieri dell'apocalisse, i signori del cemento Graci, Rendo, Costanzo e Finocchiaro, che collezionavano tutti gli appalti. Giulio Andreotti, assolto dalle colpe mafiose, fa il padre della Patria. I nobili, dai Tasca d'Almerita in giù, son tutti lì nei palazzi di campagna tra migliaia di ettari di vigneti a saggiare la gradazione dei loro vini, che vendono a milioni di ettolitri. I mafiosi della nuova generazione non ammazzano poi più tanto, fanno il "pizzo", con i piccoli imprenditori consenzienti.
Compreso Totò Schillaci che, dismesse le insegne mondiali, chiede protezione ai picciotti per difendere la sua scuola di calcio palermitana. Il procuratore capo Francesco Messineo, annunciando di aver sgominato il racket del pizzo della Noce - diciassette arresti l'altro giorno - dice che ci sono "emergenze criminali ben più intense nel paese", ma condanna l'acquiescenza dei negozianti che pagano ormai il pizzo come fosse una legittima tassa comunale. E il sostituto Alfredo Morvillo - quarantotto arresti due giorni dopo - quella della politica complice, che ha istituzionalizzato la Palermo dei favori. E favori è dir poco.
Tira scirocco su Palermo. Leoluca Orlando, che il 4 febbraio affronterà le primarie per la candidatura a sindaco la prossima primavera, dice che non c'è più "un punto unico di sintesi del potere, in assenza di ogni cultura di governo e di sano comando". Un "partito del nulla", una borghesia mafiosizzata, un blocco sociale spurio, un'economia assente, se non per il "keynesismo delinquenziale" che negli ultimi cinque anni ha dilapidato ventimila miliardi di lire dell'Unione europea in chiese, formazione professionale, precari e clientele varie. Il capo del "partito del nulla" siede a palazzo dei Normanni sulla poltrona di presidente della regione. Si chiama Totò Cuffaro, detto "Puffaro", per via del fisico brevilineo e rotondo (lui, comprensivo, si definisce un po' "pacchionello") o "Zu Vasavasa" per i baci che schiocca a tutti quelli che incontra, soprattutto ai matrimoni e ai battesimi, che sono il suo palco politico preferito. Alle signore incinte è riservata, per sua dichiarazione, una toccata del pancione. Sotto processo per favoreggiamento di Cosa Nostra, Cuffaro ha 18.239 dipendenti, di cui 5.016 precari, più 30.745 lavoratori forestali, con un bilancio di 26 miliardi, di cui 17 per stipendi e 8 per la sanità, e un archivio privatissimo computerizzato con i nomi e le abitudini di 50 mila elettori.
La sanità, ecco la cornucopia, il grande business politico e personale del governatore, che è medico, e che in materia è titolare di un record mondiale: 1.720 strutture mediche private accreditate e convenzionate in Sicilia, contro le 70 in Lombardia. Roberto Formigoni, che come lui a Milano ha ottime entrature "cielline" e sanitarie, può andare a nascondersi. Proconsole cuffariano nella sanità - o piuttosto viceversa - è don Luigi Verzè, il prete della multinazionale "San Raffaele", portatore dell'evangelica missione di curare bene i ricchi, che vola in jet privato e che il papa Paolo VI in persona accusò del peccato terreno di voler fare soltanto soldi. E Michele Aiello, presunto prestanome del boss Bernardo Provenzano, che da costruttore di strade interpoderali, con "Puffaro" si è fatto, a sua volta, ras locale della sanità.
Dal bar-ristorante Lacuba di piazza dei Marinai, ritrovo fighettoso di destra, vigila Gianfranco Micciché, come sempre eccitatissimo. Figlio di un dirigente del Banco di Sicilia, strappato agli ozi palermitani da Marcello Dell'Utri che lo assunse in Publitalia, Micciché è tuttora considerato l'artefice del voto che consegnò Palermo e la Sicilia a Silvio Berlusconi con sessantuno deputati su sessantuno. Fama che oscura persino quella ben meritata di suo fratello Gaetano, stella crescente di Imi-San Paolo-Intesa, il polo bancario di Giovanni Bazoli, Corrado Passera e Enrico Salza, supersimpatizzanti dell'attuale maggioranza governativa prodiana.
Bella coppia Cuffaro-Miccicché: "La vecchia mafia dell'Udc e la nuova mafia di Forza Italia", li bolla senza tanti complimenti Leoluca Orlando, che, se vincerà le primarie, è convinto di tornare sindaco, anche se il centrodestra spaventato gli opporrà l'ex ministro socialdemocratico Carlo Vizzini. Poi, giù giù per li rami, Enrico La Loggia, figlio di superba tradizione democristiana, ma considerato più verboso che fattivo, e Diego Cammarata, il sindaco, semplice soldato del partito del nulla: "A Palazzo dell'Aquila e dintorni - sintetizza Orlando, che alle primarie se la deve vedere con la candidata diesse Alessandra Siragusa - vivono le tre scimmiette che non vedono, non sentono, non parlano, semplicemente esternalizzano le funzioni e gli affari". Per gli appalti bisogna scendere al porto e fare anticamera dal presidente Nino Bevilacqua, che tiene il relativo sportello. Agli eventi ci pensa Davide Rampello, alle attività sociali monsignor Diliberto dalla parrocchia di San Gaetano di Brancaccio, a tutto il resto Silvio Liotta, ex segretario generale dell'Assemblea regionale e protesi vivente del Micciché, quello del bar-ristorante di piazza dei Marinai. Poi una pletora di lobbisti e avvocati d'affari, tra i quali brilla Nicola Piazza, cui si dice che piacerebbe assai fare il Guarrasi del nuovo millennio.
E il sindaco? Dicono che ricordi Carmelo Scoma, un suo predecessore degli anni Settanta che, scendendo da Palazzo dell'Aquila, dove si soffermava non troppo a lungo, e incrociando il cronista Armando Vaccarella lo apostrofava: "Armà, novità oggi in comune? " Ma quando Cammarata va a mangiare a Mondello lascia a Palazzo dell'Aquila 5.820 dipendenti, 3.353 precari, lavoratori socialmente utili pagati con trasferimenti statali, 3.402 lavoratori del "pip" (niente equivoci, per favore, è l'acronimo di piano inserimento professionale), pagati con trasferimenti regionali e una macchina comunale che costa 25 milioni al mese, su un bilancio complessivo di 3 miliardi e 202 milioni. Alla nuova e un po' scalcinata università del potere palermitano hanno detto che degli elettori devi possedere le anime: e qual è il modo migliore se non la distribuzione di lavori precari, che consegnano migliaia e migliaia di anime all'arbitrio dei politici? "Chi è potente? Chi ha assai - dice un vecchio proverbio siciliano - e chi non ha niente".
Tira scirocco su Palermo, si annuvola, ma nel grigio che incede sparano dai muri centinaia di manifesti rosso fuoco di tutte le dimensioni, insidiati soltanto da quelli della candidata diessina alle primarie, che illustrano le magnifiche sorti e progressive della città: "La Zisa, patrimonio ritrovato", "Il tram non è più un desiderio", "Anello ferroviario verso il traguardo", "Restaurate statue e fontane, splende il giardino inglese", "Palermo, rinascimento a colpi di cantiere". Salvo poi scoprire che il tram è un desiderio, l'anello ferroviario un sogno, il risanamento del centro e della Vucciria un incubo e il rinascimento una bella favola.
Si dovevano portare 50 mila nuovi residenti, da sommare ai 21 mila superstiti, ma l'ultimo censimento del degrado conta 282 immobili cadenti, 90 dei quali abitati; dei 70 milioni di euro di contributi pubblici, ne sono stati utilizzati non più di 30 mila. Il panificio, la macelleria, la drogheria a piazza del Garraffello sono sbarrate, di notte ci si aggira in un deserto surreale e terrificante. Peggio di trentacinque anni fa quando il risanamento del centro storico era l'oggetto dei pranzi al "Charleston" di Gaetano Caltagirone, palazzinaro di fede andreottiana, con il segretario socialista Giacomo Mancini. Ma a onor del vero, tra i tanti che sparano dai muri scrostati, c'è anche un manifesto non truffaldino: "Palermo a cinque stelle", dice.
E non mente: sorgono come funghi alberghi a quattro e cinque stelle, in vecchi palazzi storici, in dimore nobiliari, in nuovi grattacieli vetrati. Non si contano più le inaugurazioni. Francesco Caltagirone Bellavista, dell'Acqua Pia Antica Marcia, con il San Domenico di Taormina, l'Excelsior di Catania e l'Hotel des Estrangers di Siracusa, ha preso a Palermo Villa Igiea e l'Hotel des Palmes. Grandi pezzi di storia. Per dirne una, al des Palmes visse per mezzo secolo senza mai uscirne il barone Giuseppe Di Stefano di Castelvetrano, chi dice per una condanna alla reclusione di lusso per uno sgarbo alla mafia, chi dice - come Gaetano Savatteri, autore per Laterza de "I Siciliani" - perché non aveva una lira e l'albergo lo ospitava gratuitamente in cambio della pubblicità che faceva alla casa invitando famosi personaggi, da Maria Callas a Mario Del Monaco, da Renato Guttuso a Carla Fracci.
"Una banalità ricorrente", secondo Leoluca Orlando il rilancio di Palermo come città turistica di lusso. E lo stesso Caltagirone, che sta investendo molti denari qui, come a Venezia e in Liguria, dice che sì, che "Palermo e la Sicilia sono un museo a cielo aperto, il turismo può essere un motore, ma non l'unico". E sapete di che si lamenta per le sue attività in Sicilia, terra d'origine della sua famiglia? Del "potere frazionato, che non decide, delle burocrazie che contano più della politica, delle furbizie italiane elevate qui all'ennesima potenza". E ha anche una ricetta: "Governi di grande coalizione a Roma e in periferia". Una specie di governo come quello che tentò a Palermo Silvio Milazzo, con democristiani, missini e comunisti? Più o meno le stesse lamentele di Caltagirone quelle del patron del Palermo Maurizio Zamparini, che vuole costruire una Zamparini-City - il potere del calcio funzionale alle speculazioni immobiliari - su 288 mia metri quadrati al confine dello Zen: un centro commerciale di 30 mila metri quadri tra Roccella e Brancaccio, corredato di servizi e impianti sportivi. Vicino ci vuol fare il nuovo stadio, al posto del velodromo, ma avverte i politici: datemi l'ok subito, pena la perdita dei campionati europei del 2012.
Tira lo scirocco su Palermo. Borghesi, nobili e politici lo sfidano a Mondello, nei circoli titolati, i veri crocicchi dei "poteri frazionati". A "La Vela", o al "Lauria", sotto lo sguardo compiaciuto del presidente Gabriele Guccione Alù. E' qui che la "cupola - non - cupola" si ricompone all'ombra del ritratto dell'ammiraglio Ruggero de Lauria. Ma non dite che è mafia.
(28 gennaio 2007)
_______________________________________________________________________
Ma su Guarrasi è anche molto istruttiva la relazione di minoranza della Commissione Parlamentare Antimafia...
_________________________________________________________________
da Gino Solitro, L’invasione americana della Sicilia
COME LA MAFIA, FRUTTO DELL’OCCUPAZIONE AMERICANA, DIVENTA ELEMENTO COSTITUTIVO DEL POTERE AUTONOMISTICO SICILIANO
Mentre italiani e tedeschi combattono fianco a fianco contro gli anglo-americani, in Calabria, un aereo con le insegne italiane, il 31 agosto 1943, atterra in incognito a Termine Imerese. Ne scende con abito civile il gen. Giuseppe Castellano. Ad attenderlo, insieme a ufficiali americani, c’è uno spilungone in borghese che si rivede l’1 settembre, quando Castellano viene rispedito dagli americani a Roma, e il successivo 2 settembre quando ritorna da Roma munito delle credenziali regie.
Dello spilungone che nessuno conosceva, se ne saprà il nome immediatamente dopo l’8 settembre, quando sui giornali di tutto il mondo appare questa fotografia.
Nella foto si riconoscono il Generale statunitense Walter Bedell Smith che sta firmando, osservato dal Generale dell’Esercito italiano Giuseppe Castellano (in borghese abito scuro) con accanto il giovane avv. palermitano Vito Guarrasi (in borghese abito chiaro).

Prima di proseguire, ci sembra opportuno presentare tre personaggi della storia di quei giorni e di riassumere i fatti che precedettero l’ormai famigerato 8 settembre.
Chi era Castellano? Non siciliano come molti hanno scritto, ma un toscano di Prato. L’amicizia con Galeazzo Ciano gli agevo- lò l’entrata nello Stato Maggiore e nella corte Sabauda, dove il conte Pietro Acquarone (diventato d’Acquarone perché creato duca dal re per il buon maneggio dei suoi soldi) era ministro della Real Casa e al tempo stesso viscido orditore della trama trasversale in cui - scrive Filippo Anfuso8. - “La parte principale è, come sem- pre, riservata al congiurato Eisenhower: lo scroscio delle sue bombe decide anche gli incerti ad associarsi al complotto”.
Il 19 luglio 1943, nonostante lo status di città aperta, Eisenhower aveva infatti ordinato il cruento bombardamento di Roma nel momento stesso che Mussolini stava tornando da Feltre, dopo aver incontrato Hitler. Era il segnale che i congiurati aspettavano per aggiustarsi la maschera e inscenare il 25 luglio cui seguirà l’arresto del Duce a Villa Savoia architettato dal gen. Castellano.
Il 12 agosto, accompagnato dall’interprete Franco Montanari, Acquarone manda (col nome posticcio di Rammendi) il gen. Castellano a Lisbona in treno, via Madrid, per far sapere agli am- basciatori Alleati la disponibilità italiana ad arrendersi. A Lisbona, il Nunzio apostolico lo aiuta a superare la diffidenza dei diplomatici che lo inviano ad Algeri per indicare a Eisenhover le posizioni militari dei tedeschi in Italia e per ricevere istruzioni sul da farsi.
Chi era Vito Guarrasi? Un promettente avvocato di Alcamo, capitano di complemento corpo Autieri del Regio esercito, già in amicizia con Charles Poletti, capo dell’AMGOT in Sicilia, e con gli ufficiali-gangster del suo staff: Vito Genovese e Lucky Luciano, in intimità con l’aiutante di campo del gen. Castellano, Galvano Lanza di Trabia, il quale aveva come amministratore dei suoi feudi Calogero Vizzini. E Calogero Vizzini era il capo indiscusso della mafia siciliana, implicato in cinquantuno omicidi, nipote di due vescovi e fratello di due preti.
Torniamo alla sera del 2 settembre, quando Castellano torna da Roma con le credenziali firmate dal Re. A prelevarlo va nuovamente Vito Guarrasi e nel pomeriggio del 3 settembre raggiungono insieme l’uliveto delle Vignazze in prossimità di Cassibile, dove è piantato l’accampamento americano. Castellano, con Guarrasi accanto, sotto il tendone della mensa ufficiali, sottoscrive la resa che obbliga il governo di Badoglio a ordinare alle forze armate italiane di arrendersi, senza condizioni agli Alleati, nelle cui mani saranno consegnate tutte le armi terrestri, la marina e l’aviazione.
A firma avvenuta, Eisenhower, che osservava in fondo alla tenda, si avvicina al tavolo per dire a Castellano che la notizia della resa italiana dovrà essere simultaneamente divulgata allo sbarco di nuove forze alleate sulla penisola, poi gli tende la mano e lo congeda dicendogli che lo considera suo collaboratore.
Immortalata la stretta di mano, quando i fotografi puntano gli obiettivi sugli altri personaggi presenti in fondo alla tenda, Eisenhover li ferma con un gesto perentorio della mano. Si disse per salvare il decoro di chi non doveva trovarsi lì in divisa di ufficiale dell’esercito italiano, qual era Galvano Lanza di Trabia. La vulgata vuole, invece, per impedire che insieme con lui fosse ritratto Calogero Vizzini.
_____________________________________________________________________
Mafia, pg Palermo su Dell’Utri: “Mediatore tra Berlusconi e Cosa nostra”
Il procuratore generale nella sua requisitoria, che terminerà il 18 gennaio, ha accusato l'imputato di aver mediato con la criminalità organizzata facendo da garante per l'amico e di aver così anche "beneficiato" della vicinanza con Mangano e di questi "contatti" per avanzare nella sua carriera politica. Il 4 marzo è attesa la sentenza
di Redazione Il Fatto Quotidiano | 11 gennaio 2013
“Oggi ci chiediamo: ma Marcello Dell’Utri è un capace uomo d’affari, un intellettuale raffinato o è quello che ci hanno descritto quaranta collaboratori di giustizia, un uomo che avrebbe riciclato denaro di Cosa nostra investendo tramite Silvio Berlusconi in Milano 2? O che avrebbe posto sotto protezione Berlusconi contro i sequestri, con una generica mediazione tra il mondo imprenditoriale di Berlusconi e gli interessi economici di Cosa nostra? Ci troviamo di fronte a una vittima di 20 di attività giudiziaria o ci troviamo di fronte a un uomo che nel male ha vissuto e che ha inquinato la vita imprenditoriale di questo paese rafforzando gli interessi di Cosa nostra?”. Inizia con una domanda retorica, considerato l’interlocutore, la requisitoria del procuratore generale Luigi Patronaggio davanti alla Corte di Appello di Palermo, presieduta da Raimondo Lo Forti per il processo di secondo grado al senatore tra i fondatori di Forza Italia e tra gli uomini più vicini al Cavaliere, che ancora ieri nella trasmissione “Servizio Pubblico” lo ha definito “perbenissimo”. Il processo a Dell’Utri, dopo l’annullamento della Cassazione con rinvio della condanna a 7 anni, è iniziato lo scorso luglio.
Secondo il pg gli attentati a Silvio Berlusconi e alla Standa negli anni Ottanta e Novanta si inseriscono “nell’ottica di un rapporto complesso tra i due. La tensione e le pressioni costanti su Berlusconi permettono a Dell’Utri di uscirne rafforzato sia nella sua posizione di garanzia nei confronti dell’amico, che nei confronti della mafia per la sua posizione di mediatore”. Sugli attentati all’imprenditore che è diventato un politico nel 1994 “i pentiti parlano di interventi ai massimi livelli mafiosi per fare cessare gli attentati, il nome che fanno è quello di Marcello Dell’Utri”. Il pg ha ricordato come, secondo i collaboratori di giustizia, della vicenda si interessarono anche i “palermitani” e in particolare Totò Riina “perché non si poteva fare uno sgarro a Dell’Utri”, che avrebbe pagato “tre milioni al mese di pizzo per la Standa”.
“La condotta di Marcello Dell’Utri non può limitarsi a un concorso a un’estorsione. Ma parliamo di due condotte che si esplicano attraverso la mediazione di un’estorsione da un lato e dall’altro attraverso la funzione di garanzia delle attività di Berlusconi protette e agevolate da Cosa nostra – ha continuato il magistrato – Dell’Utri ha agito per un fine personale ben preciso giovandosi anche della vicinanza con Vittorio Mangano. Dell’Utri, se non avesse avuto alle spalle la potenza di Cosa nostra avrebbe fatto all’interno di Fininvest la scalata che ha fatto? Da oscuro impiegato di banca sarebbe andato a capo di Publitalia? Senza questo ‘valore aggiunto’ di Cosa nostra l’imputato dove sarebbe arrivato? Che carriera politica poteva fare?”.
Nel corso del suo intervento, il Pg ha anche letto il capo d’imputazione di Dell’Utri nel procedimento per la trattativa Stato-mafia (ieri la Procura di Palermo ha ribadito la richiesta di rinvio a giudizio per undici imputati, ndr) ma il documento non è agli atti del processo
___________
Dell’Utri, per i giudici fu “l’uomo cerniera” con Cosa nostra. Fino al 1992
La condanna a sette anni per concorso esterno nel nuovo processo d'appello arriva dopo vent'anni di inchiesta. La Corte d'appello di Palermo riconosce l'ex senatore Pdl colpevole fino agli anni che precedono la nascita di Forza Italia. La reazione: "Mi accusano solo perché ho conosciuto Mangano e Cinà"
di Giuseppe Pipitone | 25 marzo 2013 Il Fatto Quotidiano

Otto mesi di udienze, due processi di appello, un’inchiesta lunga vent’anni e appena sei ore di camera di consiglio per decretare che Marcello Dell’Utri è stato effettivamente l’uomo cerniera tra Cosa Nostra e Silvio Berlusconi. I giudici della terza sezione della corte d’appello di Palermo hanno dato ragione al sostituto procuratore generale Luigi Patronaggio, condannando l’ex senatore del Pdl a sette anni di carcere. “La corte conferma la sentenza del primo processo d’appello” ha detto il presidente Raimondo Lo Forti, leggendo la sentenza in pochi minuti. A pochi metri da lui l’ex senatore del Pdl incassava il colpo non tradendo la minima emozione. “E pigliamoci pure questa – è stato il commento a caldo di Dell’Utri che si è rapidamente allontanato tra la pioggia – posso essere accusato di concorso esterno solo perché ho conosciuto Mangano e Cinà? Negli anni ’70 era normale conoscere persone che poi si sarebbero rivelate mafiose. Anzi era un’ambizione”.
Ma non si tratta soltanto di Vittorio Mangano. Anche per i giudici del secondo processo d’appello Dell’Utri ha agevolato tutta Cosa Nostra dopo il 1977. ”Cu mancia fa muddichi (chi mangia fa briciole). Io ho voluto volare alto e per questo sono incappato in questi processi favola. Se ti stai fermo non ti sporchi” era stato il commento di Dell’Utri poco prima che i giudici uscissero dalla camera di consiglio.
Le indagini sull’ex senatore del Pdl erano cominciate nel 1994. Dopo una condanna a nove anni in primo grado, nel 2010 Dell’Utri era stato condannato a sette anni di carcere nel primo processo di appello. Nel marzo scorso però la Cassazione aveva sancito che non erano stati sufficientemente provati i rapporti tra Dell’Utri e Cosa Nostra tra il 1977 e il 1982: è il periodo in cui l’ex senatore si allontana da Berlusconi per andare a lavorare dal finanziere palermitano Filippo Alberto Rapisarda. È proprio per colmare quel buco investigativo che gli ermellini avevano ordinato un secondo processo d’appello.
Erano stati già provati oltre ogni ragionevole dubbio invece i rapporti tra Cosa Nostra e Dell’Utri fino al 1977. Sono gli anni in cui il futuro fondatore di Forza Italia conduce da Berlusconi le richieste estorsive di Cosa Nostra che negli affari milanesi avrebbe investito cospicue somme di denaro, come rivelato da collaboratori di giustizia del calibro di Domenico Di Carlo, Antonino Giuffrè e Gaetano Grado. E per “blindare” il rapporto con B, Cosa Nostra inviò ad Arcore un pezzo da novanta: Vittorio Mangano, eroico stalliere per l’ex premier e per l’ex senatore, boss di rango nella storia di Cosa Nostra.
Ma i rapporti tra la Piovra e il futuro presidente del consiglio continuarono almeno fino al 1992, con Berlusconi parte lesa e Dell’Utri mediatore e garante degli interessi di Cosa Nostra sul ras di Arcore. Interessi che per gli ermellini si sono fermati però proprio all’alba della nuova avventura politica, che con Forza Italia, il nuovo partito targato Dell’Utri, lancia B alla guida del Paese. Un periodo in cui i contatti di Dell’Utri con Cosa Nostra, nel processo per concorso esterno, non sono stati sufficientemente provati.
Del periodo post ’92 si occuperanno i giudici del processo sulla Trattativa tra pezzi delle istituzioni e Cosa Nostra, che inizierà a maggio e dove Dell’Utri è imputato per violenza o minaccia ad un corpo politico dello Stato. I contatti precedenti tra l’ex senatore e la mafia hanno invece incassato il secondo bollo di conferma in appello. Adesso è corsa contro il tempo per la prescrizione, che scatterà nel giugno del 2014. Se la suprema corte dovesse confermare la sentenza di condanna a sette anni entro quella data per Dell’Utri si aprirebbero le porte del carcere. In caso l’ex senatore sarebbe un condannato in via definìtiva per concorso esterno a Cosa Nostra, ma prescritto. “Diceva Andreotti che la prescrizione è meglio di niente” ha commentato il diretto interessato.
“Dell’Utri è un manager intellettuale o un uomo che nel male ha vissuto inquinando la vita politica e imprenditoriale di questo Paese agevolando gli interessi di Cosa Nostra?” si era chiesto il pg Patronaggio nella sua requisitoria. Oggi i giudici gli hanno fornito una risposta optando per la seconda ipotesi.
___________________________________________________________
Mafia, chiusa l’inchiesta su Antonio D’Alì: “Il senatore Pdl legato al boss Messina Denaro”
Ex sottosegretario all'Interno e presidente della Commissione Ambiente, il politico trapanese è accusato di concorso esterno. Nei fascicolo anche un'intervista de Il Fatto Quotidiano alla sua ex moglie e il trasferimento di un prefetto nemico dei clan
di Redazione Il Fatto Quotidiano | 21 giugno 2011
Ci siamo. Per l’ex sottosegretario all’Interno e attuale presidente della commissione Ambiente del Senato, Antonio D’Alì, si avvicina il momento della verità. Ieri, dopo due anni lavoro, la Procura di Palermo ha notificato al potente senatore trapanese del Pdl l’avviso della chiusura delle indagini aperte contro di lui per concorso esterno in associazione mafiosa, un atto che solitamente precede la richiesta di rinvio a giudizio. D’Alì deve adesso decidere se farsi ascoltare o meno dai magistrati. La riserva verrà sciolta nei prossimi giorni. Il senatore per il momento non parla. Intervengono invece i suoi legali, gli avvocati Stefano Pellegrino e Gino Bosco, che dicono: “È una storia che si trascina da molto tempo, adesso avremo modo di chiarire ogni cosa”.
L’inchiesta su D’Alì, celebre esponente di una famiglia di banchieri, politici e proprietari terrieri, è stata del resto tormentata. Un anno fa la procura aveva chiesto l’archiviazione dell’indagine, ma il gip Antonella Consiglio aveva respinto la richiesta e indicato nuovi elementi su cui lavorare. È stato quindi il pm Andrea Tarondo, il magistrato che più di altri si è occupato della presenza mafiosa e dell’infiltrazione di Cosa nostra nelle istituzioni trapanesi, a ricostruire in questi mesi il puzzle investigativo. La parte iniziale dell’inchiesta ruota intorno alla figura del superlatitante Matteo Messina Denaro. Il numero uno della mafia trapanese, e oggi forse di tutta l’isola, lavorò assieme a suo padre Francesco come campiere nei terreni di Castelvetrano della famiglia D’Alì. Poi nel ’93, mentre era impegnato nelle fasi operative delle stragi, Matteo si diede alla fuga. I D’Alì intanto faceva affari e Antonio si dava alla politica entrando nella nascente Forza Italia. Due pentiti, i fratelli Geraci, hanno raccontato anche di una presunta vendita fittizia di un terreno ai mafiosi, mentre altre vicende riguardanti il senatore sono emerse durante i processi per i lavori nel porto di Trapani appaltati (100 milioni di euro) per le gare della Coppa America del 2005.
Gli investigatori considerano questo è uno dei capitoli più interessanti dell’inchiesta. Durante i lavori portuali, secondo l’accusa, la mafia riuscì a infiltrarsi alla grande. I clan, secondo il pm, aveva l’appoggio del senatore e di una serie di imprenditori a lui legati. A raccontare, tra gli altri, i presunti retroscena del gigantesco affare è stato l’ex patron del Trapani Calcio, Nino Birrittella arrestato nel 2005 Ma non basta. Negli atti cìè di più e , forse, di peggio. Per esempio la storia dell’improvviso trasferimento da Trapani, nel 2003, dell’allora prefetto Fulvio Sodano, dopo che questi aveva stoppato il tentativo della mafia di riappropriarsi della calcestruzzi Ericina, una azienda confiscata al boss Vincenzo Virga. Un funzionario del Demanio, Francesco Nasca, condannato a sette anni proprio per questa vicenda, durante il processo ha parlato dei suoi rapporti con D’Alì. E spiegato di aver scritto una proposta di modifica della legge sui beni confiscati per poi consegnarla al senatore. Il tutto mentre una serie di mafiosi parlavano, nelle loro intercettazioni ambientali, proprio della necessità di modificare della legge e di far trasferire Sodano.
Infine nel fascicolo su D’Alì compare pure un’ intervista rilasciata a Sandra Amurri de Il Fatto Quotidiano dall’ex moglie del senatore, Antonietta Aula. Dopo la pubblicazione la donna ha tentato di smentire il contenuto delle sue esplosive dichiarazioni. Ma gli investigatori sono poi riusciti a trovare una serie di riscontri a quanto aveva detto. E adesso le sue parole vengono considerate uno dei capisaldi attorno a cui ruota l’inchiesta sul potentissimo presidente della Commissione Ambiente di Palazzo Madama.
di Rino Giacalone
di Rino Giacalone | 5 ottobre 2012
Voti e soldi, tanti soldi. E’ l’ultimo dei capitoli d’accusa appena scritto dalla Dda di Palermo contro il parlamentare trapanese, ex sottosegretario all’Interno e oggi presidente della commissione Ambiente del Senato, senatore Antonino D’Alì, il “barone” che aveva come campieri nei suoi terreni di Castelvetrano i mafiosi Messina Denaro, Francesco, il patriarca morto da latitante di crepacuore nel 1998, e Matteo il “regista” di stragi e faide e burattinaio della mafia sommersa e che fa impresa.
C’è un pentito che racconta, si chiama Giovanni Ingrasciotta. Le sue testimonianze sono entrate già in diversi procedimenti rilevanti, quelli relativi ai maxi sequestri di beni di due pezzi da novanta dell’imprenditoria siciliana, Giuseppe Grigoli, il “re” dei supermercati, 500 milioni di confische già confermate in secondo grado, e Carmelo Patti, il patron della Valtur, proposta di confisca ancora all’esame dei giudici per 5 miliardi di euro.
Ingrasciotta adesso potrebbe essere sentito anche nel procedimento penale contro il senatore di Forza Italia-Pdl Tonino D’Alì, accusato di concorso esterno in associazione mafiosa, procedimento con il rito abbreviato che è cominciato oggi a Palermo dinanzi al gup Giovanni Francolini e rinviato al 30 novembre. Stamane in aula (assente il senatroe D’Alì) il pm Andrea Tarondo ha calato un ulteriore asso, il verbale per l’appunto firmato da Giovanni Ingrasciotta sui rapporti tra D’Alì e i Messina Denaro.
Ingrasciotta ha parlato di affari ed elezioni. Nel 1994 quando D’Alì si è candidato per la prima volta al Senato con Forza Italia, “i Messina Denaro si diedero un bel da fare” ha raccontato Ingrasciotta: “Manifesti elettorali presidiati da uomini incaricati dai boss perché a nessuno venisse la voglia di coprirli, riunioni in casa di Grigoli”, dove su incarico di Matteo Messina Denaro, Ingrasciotta andò “a ritirare i fac simili”. Ma c’è anche altro. Matteo Messina Denaro rischiò infatti di perdere i suoi soldi che aveva versato in una finanziaria trapanese, la Fimepo che per un buco milionario e un giro truffaldino, sul finire degli anni 80, fu al centro di una indagine del procuratore Paolo Borsellino. Questa finanziaria prosciugò i risparmi di tanta gente, soprattutto a Pantelleria, ma i titolari, Salvatore e Lucio D’Ambra, padre e figlio, rischiarono grosso perché tirarono il bidone anche a Matteo Messina Denaro. Ingrasciotta ha raccontato di avere accompagnato un giorno a Trapani Matteo Messina Denaro, nella sede della Fimepo, vicino al Palazzo di Giustizia.
“Con noi – ha detto Ingrasciotta – nella sede Fimepo c’era anche D’Alì che fece da garante dei D’Ambra con Messina Denaro, ricordo la scena che quando finì la discussione Matteo diede una pacca sulla spalla a D’Ambra senior come per dire stavolta l’hai scampata”. L’accusa contro D’Alì riguarda diversi fatti su mafia, appalti, e politica, a cominciare dalla fittizia vendita di un terreno a Castelvetrano in contrada Zangara. Il pentito Geraci (anche lui ex braccio destro di Messina Denaro) ha ammesso che personalmente e periodicamente andava presso la Banca Sicula di Trapani, banca dei D’Alì, ritirando in diverse tranche la somma di 300 milioni di vecchie lire, la cifra che lo stesso Geraci da prestanome dei Messina Denaro aveva consegnato al notaio alla stipula dell’atto. Geraci ha raccontato che Messina Denaro avrebbe fatto incetta di terreni perché l’idea era quella di costruire una sorta di “Castelvetrano 2”, sul modello “milanese”.
Sul deposito del verbale di Ingrasciotta ha fatto oppsizione la difesa asserendo che con l’abbreviato non è prevista l’introduzione di nuove prove. Il gup, Giovanni Francolini, si è riservato di decidere ed ha fissato la nuova udienza al 30 novembre.
I BUCHI NERI DEL SENATORE
di Enzo Guidotto
Dopo “Report” e “Anno Zero”, anche “Blu Notte” ha fatto conoscere all'opinione pubblica nazionale certi fatti antichi e recenti della mafia trapanese suscitando l'ormai consueta indignazione nei “soliti noti”, convinti che i panni sporchi vadano tenuti nascosti o, tutt'al più, lavati in casa. In compenso, contrariamente a quanto avvenuto l'anno scorso con i collaboratori di Michele Santoro, stavolta il senatore Antonio D'Alì ha risposto con modi garbati, linguaggio felpato e tono pacato alle domande di Carlo Lucarelli per spiegare la natura del rapporto fra la sua dinastia e quella dei Messina Denaro.
«Storicamente – afferma il conduttore della trasmissione – uno dei punti di contatto fra mafia e società civile è il latifondo: i proprietari terrieri stanno lontano, in città, ed hanno bisogno di qualcuno che amministri le loro terre, magari usando il pugno di ferro. Nel Trapanese, sulle terre dei D'Alì, c'è Francesco Messina Denaro» di Salvatore.
600 dipendenti - «Negli anni Cinquanta – precisa D'Alì - la mia famiglia aveva la più cospicua possidenza agraria e circa 600 dipendenti sparsi in tutta la provincia: che nell'ambito del numerosissimo gruppo di dipendenti ci possano essere state anche persone che a seguito di indagini si siano rivelate appartenenti alla criminalità organizzata, credo che in Sicilia fosse difficile poterlo evitare e soprattutto poterlo prevedere».
Non si può escludere che il senatore sia stato sincero nel senso che ha detto quel che sa: nato il giorno di Natale del 1951, non può essere testimone di quelle vicende. Ma, se volesse prendersi la briga di indagare a fondo si renderebbe conto che le cose, in realtà, sono andate diversamente: basterebbe scartabellare l'archivio di famiglia o interpellare qualche anziano parente.
Stando alle dichiarazioni fatte l'anno scorso ad “Anno Zero” dallo zio Antonio, nella scelta di Francesco Messina Denaro come dipendente non c'era stato nulla da “prevedere” per “evitare” perché nell'ambiente la sua personalità era ben nota. Don Ciccio – ha detto - lavorò a Castelvetrano «come campiere, dopo la guerra. La mafia allora era diversa. Ci si poteva avere a che fare con quella gente lì. Insomma, inizialmente, era (si badi bene: non “sembrava” ma «era»!, ndr) una brava persona, non una persona dalla quale bisognava stare alla larga». Nella famiglia D'Alì, dunque, esisteva sin dall'epoca dell'assunzione la consapevolezza piena, chiara e netta dell'appartenenza a Cosa Nostra di quel collaboratore che tale rimase anche dopo essersi reso responsabile di vari crimini.
Matteo? “Terza generazione” - Ulteriori elementi sulla sua caratura delinquenziale si potevano peraltro desumere dal fatto che in realtà Matteo Messina Denaro non appartiene alla seconda ma «alla terza generazione di una famiglia da sempre in Cosa Nostra» dato che il nonno Salvatore «se l'era sfangata dalla repressione di Mori all'imperversare di Giuliano». L'interessante notizia l'ha fornita Alfio Caruso, giornalista del “Corriere della Sera”, nel libro “Cose di Cosa Nostra” pubblicato nel 2000. Per la cronaca, Cesare Mori, operò a Castelvetrano da commissario di polizia dal 1904 al 1914 ed a Trapani e Palermo da prefetto dal 1924 al 1928, anno in cui nacque Francesco. Salvatore Giuliano morì nel 1950.
Negli anni immediatamente successivi Francesco, figlio di Salvatore e padre di Matteo – si legge in un “Memoriale” della Federazione del PCI di Trapani consegnato alla Commissione parlamentare antimafia della sesta legislatura (1972-1976) – risulta implicato in fatti assai eclatanti: varata la Riforma Agraria, «all'ombra della legge per la formazione della piccola proprietà contadina si perpetra in provincia la truffa colossale a danno dei lavoratori e lo sfacciato illecito arricchimento dei mafiosi». Nella zona di Castelvetrano, per la vendita dell'ex feudo “Campana” «si mobilita un nutrito nugolo di mafiosi, tra i più noti della zona» che comprende, oltre al nostro personaggio, persino un affermato notaio. A un certo punto, però, si scatenano «furibondi odi» per la «divisione dei frutti», per cui «il gruppo diviso e in mortale contrasto» passa «dalle vendite della terra alla propria autoeliminazione con la lupara». Fra i sopravvissuti, il vecchio Francesco Messina Denaro che andrà avanti lungo il solco tracciato diventando componente della commissione regionale di Cosa Nostra e, malgrado tutto, rimarrà alle dipendenze dei D'Alì fino al 1988, quando si dà alla latitanza, lieto di aver assicurato un tranquillo avvenire al figlio Salvatore junior, fatto assumere alla Banca Sicula di proprietà dei D'Alì e di lasciare lo scettro al prediletto Matteo, all'anagrafe agricoltore, che percorrerà una folgorante carriera criminale: già nel febbraio dell'89 è denunciato a piede libero per associazione mafiosa; nel ‘91 incassa dall'INPS quattro milioni come indennità di disoccupazione: ad averli pagati era stato Pietro D'Alì, fratello del senatore Antonio (“Narcomafie”, V.2007); nel ‘93 partecipa alla strategia stragista nel Centronord e per farla franca diventa uccel di bosco. «Nel 1994 – ha raccontato agli inquirenti il “pentito” Vincenzo Sinacori – Matteo dette l'ordine di votare Forza Italia». E quell'anno, nella lista per il Senato, si sa, c'era un solo candidato.
I gabelloti di Paceco - Se le cose sono andate così, per dirla col poeta, oggi a Trapani ci sarebbe «qualcosa si nuovo, anzi d'antico» , perché – c'è scritto nel citato memoriale agli atti dell'Antimafia – anche nei passati decenni, in provincia, si notava un' «atmosfera impregnata della collusione fra forze politiche e mafia». Ma, «a differenza delle altre province occidentali della Sicilia, nel Trapanese la mafia non è arroccata unicamente alla Democrazia Cristiana, ma segue l'orientamento dei grossi interessi economici e sociali che serve e da cui trae profitto nella sua intermediazione tra patronato e lavoratori». Gli esempi non mancano ed il primo si riveIa illuminante: «I gabelloti dell'agrario D'Alì, grossi nomi della mafia di Paceco, seguono le piste politiche del loro protetto e protettore».
Calunnia destituita di fondamento? Gli interessati sono ormai morti. Se però se si va in piazza a Paceco e si chiede un parere sulle dichiarazioni fatte dal senatore in televisione la risposta delle memorie storiche è unanime: «Sùlu Francesco Messina Denaro a Castelvetrano? Ma quànnu mai? Pùru ccà i gabelloti dei D'Alì eranu capimafia: basta pinsàri a Cicciu D'Angelo, chiamatu “Cicciarèddru”, nnò feudu “Tamburellara”; a Vito Sucameli, ntìsu “Nasca”, nnò feudu “Bellingeri” e ai loro gregàri». Solo dipendenti? «E pùru influenti!» precisa un omino che si regge sul bastone. In che senso? «Unu di chissi fici “pùnciri” puru a sò figghiu: parìa chi cuntava menu, ma so frati si mpustàu a Banca Sicula, e u postu passàu in eredità a un figghiu. Ci finìu mègghiu di Salvatore Messina Denaro, figghiu di Cicciu e frati di Matteo: l'arrestaru pi mafia e fu scuppàtu fòra».
Come prima, più di prima - Ma non c'è solo questo. «Un niputi di “Cicciareddru” e fràti di mafiusu – dice un altro - trasìu à Banca del Popolo e fu puru sindacu di Paceca. E quando le autorità lo hanno interpellato sulla reputazione di Girolamo Marino, detto “Mommu ù nànu”, iènnaru di “Nasca” e capomafia dopu a iddru, c'arrispunnìu:”E' una persona rispettabilissima”. Ecco qua, l'hanno scritto anche in una rivista nazionale». E mostra la fotocopia dell'articolo di “Panorama” del 22.6.1981. Il nome del sindaco? Giuseppe D'Angelo.
Nelle stesse pagine ci sono nomi del Gotha mafioso trapanese del momento, tra i quali campeggiano quelli dei Minore (uno dei quali, Antonino, secondo quanto scrive Caruso, fu impiegato dai D'Alì nella tenuta di Contrada Bianca) e dei Marino, ma anche notizie sui finanziamenti della Regione e della Cee a certe aziende del settore vinicolo, lo stesso nel quale sono oggi in corso inchieste e processi per truffe a carico di rampolli della “Marino dinasty” – due dei quali incriminati anche per triplice omicidio commesso a Brescia - e dei loro finora “presunti” complici. Secondo qualcuno, i finanziamenti arrivavano attraverso “parlatine” di politici. E, guarda caso, il presidente di una delle società sequestrate è fratello di un ex candidato sindaco del centro destra.
Qualcuno ne sa qualcosa?
Enzo Guidotto
___________________________________________________________
venerdì 11 gennaio 2013



Mafia, capi e famigli: Guarrasi, Dell’Utri, D’Alì...