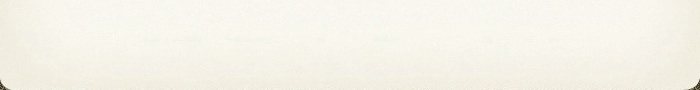Materiali
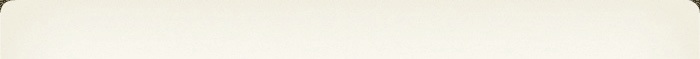



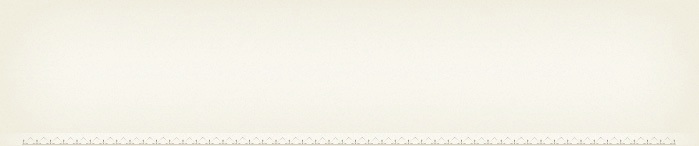

L' economia criminale (2000, da ‘Le Monde Diplomatique’)
Cessioni di sovranità e globalizzazione liberista che permettono ai capitali di circolare senza controllo da un capo all'altro del mondo hanno favorito l'esplosione di un mercato finanziario fuori legge che, lubrificato dai profitti della grande criminalità, è diventato il motore dell'espansione capitalista. Governi, mafie e società transnazionali, soci in affari nell'arcipelago planetario del riciclaggio del denaro sporco, prosperano nelle crisi e si abbandonano in tutta impunità al saccheggio della cosa pubblica. Operazioni di facciata vengono lanciate di tanto in tanto contro i paradisi bancari e fiscali in piena espansione, per gettare fumo negli occhi e dare l'illusione che li si sta combattendo, quando i governi, se veramente ne avessero l'intenzione, potrebbero metterli in condizioni di non nuocere nello spazio di una giornata. Alla "tolleranza zero" raccomandata un po' dappertutto contro la piccola delinquenza del precariato e della disoccupazione fa da contraltare la "repressione zero" contro la grande criminalità finanziaria. (Dossier alle pagine 8, 9, 10 e 11)
Di Christian de Brie *
Sistematicamente messa in luce dagli "scandali" che incidentalmente coinvolgono, in un paese o in un altro, un'impresa o una banca, un dirigente o un partito politico, un cartello o una mafia, la criminalità finanziaria sembra impenetrabile. Questa massa di transazioni relative ad operazioni illecite considerate delitti o semplici infrazioni a seconda delle legislazioni nazionali o degli accordi internazionali viene solitamente fatta passare per una serie di accidentali disfunzioni dell'economia e della democrazia liberale, che una "buona azione di governo" è comunque in grado di riassorbire. Il contrario esatto di ciò che è in realtà: un sistema coerente, intimamente legato all'espansione del capitalismo moderno, basato sul sodalizio fra tre partner: governi, imprese transnazionali e mafie. Ma gli affari sono affari: la criminalità finanziaria è innanzitutto un mercato, ove vige la legge della domanda e dell'offerta business as usual.
Le grandi organizzazioni criminali devono necessariamente avvalersi della complicità degli ambienti affaristici e del "laisser-faire" del potere politico per poter far fruttare, mediante il riciclaggio, i profitti eccezionali delle loro attività.
Per rafforzare le loro posizioni e aumentare i guadagni, smantellare o contrastare la concorrenza, assicurarsi "contratti del secolo", finanziare le loro operazioni illecite, le imprese transnazionali hanno bisogno del sostegno dei governi e della neutralità degli organi di regolamentazione. Quanto al personale politico, diretta parte in causa, il suo potere d'intervento è legato agli appoggi e ai finanziamenti che ne garantiranno la perpetua inamovibilità. Questa collusione d'interessi costituisce una componente essenziale dell'economia mondiale, il lubrificante indispensabile per un "buon" funzionamento del capitalismo. Un funzionamento che è stato notevolmente perfezionato per effetto di tre fattori congiunti. La completa liberalizzazione dei movimenti di capitali che, dalla fine degli anni 80, sfuggono ad ogni forma di controllo, nazionale o internazionale. La dilatazione e smaterializzazione delle transazioni finanziarie, accelerate dalla rivoluzione tecnologica delle comunicazioni. Infine, la sempre maggiore affidabilità di un arcipelago planetario di aree specializzate nella gestione compiacente della criminalità finanziaria: i paradisi fiscali (si legga l'articolo a pag 9).
La rivoluzione non è una cena di gala, diceva Mao Tse-tung. Tantomeno lo è la concorrenza, che sembra avere poco a che fare con quei tornei di prodi cavalieri declamati dai cantori delle epopee liberiste, in cui, illuminato dalla grazia del Dio-mercato, vince il migliore miglior prodotto, miglior servizio e miglior prezzo. Come nei duelli feudali, per vincere la guerra economica è invece concesso ogni colpo, anche il più basso. Quanto alle armi, non manca di certo la scelta: intese e cartelli, abusi di posizione dominante, dumping e vendite forzate, aggiotaggi e speculazioni, assorbimento o smembramento della concorrenza, falsi in bilancio, manomissioni dei libri contabili e dei costi di trasferimento, frodi e evasioni fiscali attraverso filiali off-shore e società-ombra, sottrazione di crediti pubblici e mercati truccati, corruzione e commissioni occulte, arricchimenti illeciti e abusi di beni sociali, vigilanza e spionaggio, ricatti e delazioni, violazioni dei regolamenti in materia di diritto del lavoro e libertà sindacale, di igiene e di sicurezza, di contributi sociali, di inquinamento e rispetto ambientale (1). Ad esse vanno aggiunte le pratiche in vigore nelle zone franche che prosperano ormai nel mondo intero, anche in Europa e in Francia (si veda la cartina a pagina 9), zone di non-diritto, totalmente o parzialmente al di fuori delle leggi ordinarie, soprattutto in materia sociale, fiscale e finanziaria (2).
Possiamo ritrovare tali operazioni in tutti i grandi settori d'attività e su tutti i mercati: armamenti, petrolio, lavori pubblici, aviazione civile, trasporto aereo, ferroviario e marittimo, telecomunicazioni, banche e assicurazioni, settore chimico e agro-alimentare Ad esse sono legate notevoli sottrazioni di fondi, che escono dai libri contabili delle società trasnazionali per approdare in qualche paradiso fiscale. Un saccheggio fenomenale, di cui non sarà mai dato il minimo conto globale.
Per realizzarlo, i loro autori hanno bisogno del potere dello stato e di quello degli organismi nazionali e internazionali, soprattutto della loro capacità di promulgare regolamentazioni vincolanti il minimo possibile e di sopprimere o rendere inapplicabili quelle già esistenti, procrastinando all'infinito o paralizzando le inchieste e le istruttorie e riducendo o amnistiando le eventuali pene. In cambio si offrono di "finanziare la democrazia". E si danno un bel da fare: campagne elettorali per alcuni partiti, promozione delle personalità politiche o degli alti funzionari più promettenti, seguiti e "marcati stretti" da un esercito di consulenti, vere e proprie lobby, presenti in tutti gli organismi decisionali (3), incaricate di aiutarli a fare la "scelta giusta" e di corromperli.
Infine, non hanno alcuna ripugnanza a ricorrere, se necessario, ai servigi delle organizzazioni criminali professioniste. Contro i lavoratori, traffichini di ogni sorta venduti al padronato, sindacati "collaborazionisti", crumiri, milizie private e squadroni della morte imperversano nella maggior parte delle loro filiali e tra i loro fornitori delocalizzati nei paesi del Sud. Contro gli azionisti ribelli, che in Giappone, durante le assemblee generali, sono posti sotto la sorveglianza della jakuza. O, ancora, per l'esecuzione di "contratti" nei confronti di intermediari diventati troppo scomodi o di inquirenti troppo curiosi: si è perso il conto degli uomini d'affari, banchieri, politici, giudici, avvocati o giornalisti "suicidati" con un cappuccino al cianuro, impiccati o caduti dal decimo piano con le mani legate dietro la schiena, trovati con due pallottole in testa, annegati ancora vestiti in una pozza d'acqua o nella loro vasca da bagno, scivolati sotto un autobus o in una vasca piena di cemento o di acido, caduti in mare dal loro yacht pieno di guardie del corpo, scomparsi in volo o in automobile
Le banche e le grandi imprese sono interessate, più di ogni altra cosa, ad intercettare, dopo averlo riciclato, il denaro proveniente dagli affari del grande crimine organizzato. Accanto alle attività tradizionali droga, racket, rapimenti, gioco d'azzardo, sfruttamento della prostituzione (delle donne e dei bambini), contrabbando (alcool, tabacco, medicinali), rapine a mano armata, denaro falso e false fatture, frode fiscale e sottrazione di fondi pubblici prosperano oggi nuovi mercati: traffico di manodopera clandestina e di rifugiati in fuga, pirateria informatica, traffici d'oggetti d'arte e d'antiquarato, di auto rubate e singoli pezzi, di specie protette e organi umani, contraffazioni, traffici d'armi, di scorie tossiche e di prodotti nucleari
Ogni paese ospita i suoi circuiti criminali. Le organizzazioni più importanti e di più lunga data si trovano nei centri del capitalismo: negli Stati uniti (Cosa Nostra), in Europa (la mafia siciliana), in Asia (le triadi cinesi e le jakuza giapponesi). Negli ultimi decenni se ne sono però sviluppate altre, come i cartelli colombiani in America latina o le mafie russe. Centinaia di gruppi antagonisti si spartiscono i mercati nazionali e internazionali del crimine, stringendo alleanze e accordi di sub-appalto, con la tendenza a moltiplicarsi in piccole unità flessibili e mobili, specializzate su un segmento particolare o su un settore portante del mercato.
I profitti annuali del traffico di droga (cannabis, cocaina, eroina) sono stimati tra i 300 e i 500 miliardi di dollari (senza contare le droghe sintetiche, il cui settore conosce uno sviluppo eccezionale), cioè tra l'8 e il 10 % del commercio mondiale (4). Il volume d'affari della pirateria informatica supera i 200 miliardi di dollari, quello della contraffazione i 100 miliardi; quello della frode al bilancio comunitario europeo si aggira tra i 10 e i 15 miliardi di dollari, quello del traffico di animali sulla ventina di miliardi. In totale, considerando solo le attività transnazionali fra cui la "tratta delle bianche" il prodotto mondiale lordo delle attività criminali supera ampiamente i 1.000 miliardi di dollari annui, una cifra pari al 20 % del commercio mondiale.
Anche ammettendo che le spese (produzione e fornitori, intermediari e corruzione, investimenti e costi di gestione, perdite legate a sequestri giudiziari e azioni di repressione) siano pari a circa il 50% del volume d'affari, rimangono 500 miliardi di dollari annui. Cioè, su un periodo di dieci anni, 5.000 miliardi di dollari, una somma tre volte più alta delle riserve di valuta di tutte le banche centrali messe insieme (5), un quarto della capitalizzazione complessiva delle cinque maggiori piazze borsistiche mondiali, dieci volte quella della borsa di Parigi (6).
Si tratta di gestire questa somma gigantesca, che non è però possibile smaltire in piccole quantità (7). Una miniera d'oro che potrebbe mandare in fibrillazione tutti i finanzieri del mondo. E si dà il caso che proprio del loro aiuto hanno urgente bisogno le organizzazioni criminali, per riciclare questo denaro ed immetterlo nel circuito legale. Per tale operazione sono disposti a pagare profumatamente; e lo fanno, investendo circa un terzo dei profitti totali delle loro attività: 150 miliardi di dollari, divisi tra circuiti bancari e intermediari vari (avvocati, mediatori, responsabili di trust e di crediti fiduciari). Con il risultato che ogni anno vengono riciclati e reinvestiti più di 350 miliardi di dollari, cioè 1 miliardo di dollari al giorno.
Nessun settore d'attività raggiunge cifre simili e nessuno può eguagliare tale volume di scambi, pari alla metà o ai due terzi degli investimenti diretti esteri (Ide) (8).
Le organizzazioni criminali multinazionali, fedeli seguaci del mercato e della globalizzazione, di cui conoscono a menadito il funzionamento, non vanno certo ad intasare le casse di risparmio. Vanno invece a caccia dei più elevati tassi di profitto: fondi a rischio (hedge funds) e speculazioni finanziarie di cui gonfiano la bolla, mercati emergenti, immobiliare e nuove tecnologie. Assicurandosi in tal modo solidi profitti nei settori più fiorenti dell'industria e del commercio. Sono quindi il fattore lubrificante della poderosa espansione del capitalismo moderno, in un sodalizio permanente con le imprese transnazionali in cui hanno investito e con le banche che gestiscono i loro fondi. Rimane loro poi abbastanza denaro per garantirsi un certo tenore di vita e partecipare al finanziamento e alla corruzione dei partiti e degli esponenti politici, che meglio di chiunque altro sono in grado di mantenere immutato un sistema così conveniente.
Ed è proprio questo il contributo offerto dall'ultimo partner, il potere politico-burocratico, in cambio di un aiuto finanziario che gli consente di rimanere al suo posto, di riassestarsi dopo eventuali scosse, se non addirittura di arricchirsi. Suo compito è fornire l'illusione che sia in corso una lotta permanente, costantemente rinforzata e coordinata a livello internazionale governativo, poliziesco e giudiziario contro la criminalità finanziaria (corruzione, traffici, riciclaggio), senza tuttavia mettere in pericolo il funzionamento del sistema. Cambiare tutto per non cambiare niente. Il fallimento della più che trentennale guerra internazionale al narcotraffico conferma il "successo" di questa formula. Possiamo prevedere un esito simile per la lotta contro il riciclaggio del denaro sporco e la corruzione, rilanciata in modo eclatante al vertice del G 7 dell'Arche, a Parigi, nel 1989, in cui venivano mobilitati, oltre ai paesi membri, l'Organizzazione delle Nazioni unite (Onu), l'Organizzazione della cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse), il Fondo monetario internazionale (Fmi), la Banca dei regolamenti internazionali (Bri) e l'Unione europea ...
Sono stati creati organismi ad hoc (9), firmate e ratificate convenzioni internazionali sulla repressione della corruzione nei mercati internazionali (10), la collaborazione tra polizie e la cooperazione tra organi giudiziari (11), moltiplicati colloqui e studi, commissioni di inchiesta e rapporti vari. Il tutto accompagnato da grandi dichiarazioni di severità e impegno da parte dei leader, senza che il sistema della criminalità finanziaria ne sia risultato minimamente intaccato. Un sistema che sta per sconfiggere, per logoramento, anche quei pochi virtuosi che si ostinano a combatterlo, come conferma il diffuso sentimento di stanchezza provato dai giudici e dai poliziotti impegnati in Italia nell'esemplare operazione "mani pulite". O il grido d'allarme lanciato alla fine del 1996 da sette esperti giudici europei l'"appello di Ginevra" rimasto senza seguito (12).
Quanto allo smantellamento dei paradisi fiscali, paradisi del crimine e basi fondamentali per l'occultamento delle malversazioni finanziarie, è fuori discussione. Il massimo che si può fare è incitarli ad adottare codici di buona condotta, una misura tanto efficace quanto può essere affidare i trasporti di capitali alla mafia dopo averle fatto sottoscrivere l'impegno morale di sottoporre i suoi veicoli a verifiche regolari. Fuori discussione è anche la possibilità di mettere in piedi un meccanismo di cooperazione internazionale permanente, o uno spazio giuridico comune europeo, che al limite è argomento di timide discussioni, quando ora ci vogliono diciotto mesi di attesa perché una domanda di cooperazione giudiziaria inviata da Parigi a Ginevra ottenga una risposta.
Addirittura si sta sviluppando, sotto l'egida degli Stati uniti, principale partner della criminalità finanziaria internazionale, un'operazione di razionalizzazione, ovvero di americanizzazione, delle tecniche di corruzione, che mira a sostituire le pratiche, ormai un po' obsolete, delle tangenti e delle commissioni occulte (o palesi) con quella delle lobby di pressione, più efficaci e presentabili. Un settore d'attività in cui gli Stati uniti possono godere di un vantaggio considerevole rispetto ai loro concorrenti, non solo per la loro esperienza, ma anche perché le loro multinazionali possono mettere a disposizione gli enormi mezzi di intervento finanziari e logistici di cui dispongono, ivi compresa la mobilitazione dei servizi segreti del più potente apparato statale del mondo, passati direttamente dalla guerra fredda alla guerra economica.
Prova ne è il successo riportato presso i media dalla pubblicazione di un indice annuo delle quotazioni dei paesi corruttori e corrotti stabilito dalla Transparency International, una lobby che fa capo alla Cia, finanziata da governi e da imprese esperte in materia, per lo più americane, come Lockheed, Boeing, Ibm, General Motors, Exxon, General Electric o Texaco (13). Le campagne anti-corruzione, di cui si fanno portavoce gli organismi internazionali (Banca mondiale, Fmi, Ocse) non hanno altro obiettivo che la "buona gestione" di una criminalità finanziaria diventata ormai parte integrante della globalizzazione dei mercati, guidata dalla democrazia più corrotta del pianeta, quella americana.
La sfrenata corsa al profitto e all'accumulazione di capitali, con ogni mezzo, si concretizza nella spoliazione generalizzata del prodotto del lavoro umano e delle ricchezze comuni, e comporta la corruzione dei costumi della classe dirigente. Ai baroni ladri succedono ora i principi predoni.
(Traduzione di S.L.)
Christian de Brie (Le Monde Diplomatique)
___________________________________________________________
Sei in: Il Fatto Quotidiano > Economia & Lobby > I mafiosi? Impr...
I mafiosi? Imprenditori scarsi.
E la ‘ndrangheta guadagna di più al Nord
Lo studio di Transcrime dell'Università Cattolica di Milano sui quasi 20mila beni confiscati alla criminalità organizzata in quasi trent'anni stima nell'1,7% del Pil l'economia criminale. Nell'attività economica, i boss badano meno al profitto e più al "consenso sociale". La criminalità calabrese fa solo il 23% dei profitti nella regione d'origine. Il professor Savona: "Ma il crimine paga meno di quanto si pensi"
di Luigi Franco | 16 gennaio 2013

I mafiosi come imprenditori? Bocciati. Perché nelle loro attività badano più al controllo del territorio e al consenso sociale che alla reale redditività dei business in cui investono. E’ questo uno dei risultati dello studio “Gli investimenti delle mafie”, realizzato dal centro interuniversitario Transcrime dell’università Cattolica, presentato nell’aula magna dell’ateneo milanese. Una ricerca che dà diverse conferme, come l’esistenza di forti interessi economici della ‘ndrangheta nel nord-ovest del Paese. Ma sfata la convinzione che il giro di affari attorno alle organizzazioni criminali si avvicini addirittura al 10 per cento del Pil.
“Il crimine paga molto meno di quello che si dice”, assicura il direttore di Transcrime Ernesto Savona, visto che i ricavi annui legati ad attività illecite sono stimabili con una forbice che va dai 17,7 ai 33,7 miliardi di euro (il valore medio di 25,7 miliardi corrisponde all’1,7 per cento del Pil). Attraverso un’analisi scientifica di dati provenienti da fonti aperte come il database dei beni confiscati, la ricerca ha portato a mappare il territorio nazionale in base a diversi parametri, come l’indice di presenza mafiosa (Ipm), che dà una fotografia di dove le organizzazioni mafiose operano in prevalenza.
Ai 25 miliardi di euro stimati come ricavi complessivi del crimine contribuiscono soprattutto il traffico di droga (7,7 miliardi), le estorsioni (4,76 miliardi), lo sfruttamento sessuale (4,6 miliardi), la contraffazione (4,5 miliardi) e l’usura (2,2 miliardi). Le mafie non hanno il monopolio di questi business, ma se ne aggiudicano solo una fetta che va dagli 8,3 miliardi ai 13 miliardi, puntando soprattutto su estorsione (45 per cento), droghe (23 per cento), usura (10 per cento) e sfruttamento sessuale (8 per cento). Le due organizzazioni criminali più aggressive negli affari sono la camorra e la ‘ndrangheta, che si aggiudicano rispettivamente il 35 e il 33 per cento dei ricavi. Più di Cosa nostra (18 per cento) e della criminalità organizzata pugliese (11 per cento).
A differenza delle altre mafie, che ricavano una parte consistente delle proprie entrate illecite nelle regioni di origine, la ‘ndrangheta si distingue come quella che più ha colonizzato il resto d’Italia. Solo il 23 per cento dei suoi ricavi proviene infatti dalla Calabria, mentre a farla da padrone sono i clan attivi nel nord-ovest: il Piemonte pesa infatti per il 21 per cento dei ricavi, la Lombardia per il 16 per cento, seguite da Emilia Romagna (8 per cento), Lazio (8 per cento) e Liguria (6 per cento). Un dato che conferma i risultati delle ultime inchieste della magistratura, che hanno mostrato come la ‘ndrangheta abbia messo le mani sull’economia delle zone più sviluppate del Paese.
Una volta stimato il giro di affari delle mafie, lo studio si è posto il problema di come vengano investiti i guadagni illeciti. Per questo sono stati considerati i quasi 20mila beni confiscati alle organizzazioni dal 1983 al 2011. Di questi il 52,3 per cento sono beni immobili, seguiti da beni mobili (39 per cento), come autoveicoli, denaro e gioielli. I dati sui beni immobili, secondo i ricercatori di Transcrime, dimostrano che gran parte di appartamenti e terreni vengono acquistati non a fine speculativo, ma per aumentare il consenso sociale. Insomma, un boss per acquisire prestigio e rispetto punta spesso sulla villa di lusso.
Una logica analoga è sottesa anche agli investimenti in aziende e titoli societari (8,7 per cento del patrimonio delle organizzazioni criminali): le esigenze di riciclaggio e di creazione di un consenso sociale che favorisca il controllo del territorio prevalgono sugli obbiettivi di profittabilità. “Il boss, più che degli indici di redditività, si preoccupa di apparire come un punto di riferimento capace di soddisfare le esigenze di chi vive nella stessa area, come la ricerca di un posto di lavoro”, commenta il sottosegretario di Stato all’Interno, Carlo De Stefano, che ha partecipato alla presentazione dello studio insieme al vice capo della polizia ed ex questore di Milano Alessandro Marangoni.
Gran parte delle società riconducibili alle mafie hanno così diversi tratti comuni: bassa profittabilità, basso indebitamento con le banche e alta liquidità. Come forma societaria viene scelta nel 46,6 per cento dei casi la srl, il più delle volte messa in mano a un prestanome scelto nella cerchia famigliare, in modo da limitare al massimo la presenza di manager e consulenti esterni. Le aziende controllate dai boss puntano soprattutto su costruzioni, commercio, estrazioni e cave, alberghi e ristoranti. Ovvero i settori a più basso livello tecnologico, maggiore intensità di manodopera e più alto coinvolgimento della pubblica amministrazione.
-------------------------------------------------------------------------------
ndr: quanto sopra, che nasce da indicatori ‘diretti’ come i beni confiscati, trascura tutto il settore ‘legale’, ovvero gli imprenditori legati alle mafie o loro emanazione, il giro d’affari all’estero, i rapporti ufficialmente irreprensibili con grandi e piccole banche...in sostanza la cifra dell‘1,7% del PIL è largamente sottostimata. Basti pensare che altre fonti portano la percentuale del capitale investito in aziende dall‘8,7% qui citato ad almeno il 50%. Si tende cioè a trascurare la parte moderna dell’evoluzione delle mafie (escluse per ora, almeno ufficialmente, camorra e Nuova Corona Unita) che escono dal territorio e diventano capitale commerciale e finanziario. Le stime qui presentate appaiono piuttosto relative solo alla parte ‘manovale’ e militare della struttura mafiosa. (I soli Riina&C. per intendersi).
____________________________________________________________
martedì 4 dicembre 2012



economia criminale